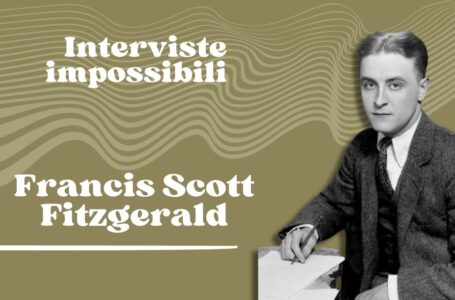Alda Merini: “Ecco perché scelsi di rimanere in manicomio”. L’intervista impossibile

Sono nata il ventuno a primavera,
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.
Chiosa così Alda Merini, in una poesia divenuta celebre, il momento in cui venne al mondo. Una vita difficile, tra alti e bassi, incompresa dai suoi genitori e dal mondo. Una malinconia albergava in lei, tanto profonda da essere considerata pura «follia», alternata a momenti di estrema lucidità e di genialità di pensiero. Per questa ragione, l’ospedale psichiatrico in cui fu rinchiusa divenne la sua casa per circa otto anni, facendo fiorire in lei l’estro della scrittura: Merini trovò la forza di trasformare il dolore dell’internamento in una fonte di ispirazione per la produzione letteraria che raggiunse il suo apice con l’opera La Terra Santa che le valse il premio Librex Montale nel 1993.
Abbiamo immaginato di poter dialogare con lei, sulla soglia del margine. Ecco la nostra intervista.
Signora Merini, vorrei ringraziarla per aver accettato di parlare con noi di un tema molto delicato: l’esperienza del manicomio. Come ha trascorso gli anni all’interno dell’ospedale psichiatrico?
Quando venni ricoverata per la prima volta in manicomio ero poco più che una bambina, avevo sì due figlie e qualche esperienza alle spalle, ma il mio animo era rimasto semplice, pulito, sempre in attesa che qualcosa di bello si configurasse all’orizzonte.
La sua vita è conosciuta, ma ci interessa conoscere il suo punto di vista. Gli anni del manicomio non devono essere stati semplici, cosa ricorda di quel periodo?
Beh, le leggi erano precise e ancora nel 1965 la donna era soggetta all’uomo e quindi l’uomo poteva prendere delle decisioni per ciò che riguardava il suo avvenire. Fui quindi internata a mia insaputa, e io nemmeno sapevo dell’esperienza degli ospedali psichiatrici perché non li avevo mai veduti, ma quando mi ci trovai nel mezzo… credo che impazzii… proprio in quel momento, impazzii in quanto mi resi conto di essere entrata in un labirinto dal quale avrei fatto molta fatica a uscire. Mi misi a urlare e a calciare con tutta la forza che avevo dentro, con il risultato che fui legata e martellata di iniezioni calmanti. Ancora oggi mi chiedo perché quella ribellione fu scambiata per un atto di insubordinazione. Dopo qualche giorno mio marito venne a prendermi ma io non volli seguirlo. Avevo imparato a riconoscere in lui un nemico e poi ero così debole e confusa che a casa non avrei potuto far nulla.
In un luogo simile, come trascorreva le sue giornate? C’erano delle regole da seguire?
Il manicomio era saturo di fortissimi odori. Molta gente orinava e defecava per terra. Dappertutto era il finimondo. Gente che si strappava i capelli, gente che si lacerava le vesti o cantava sconce canzoni. Ma d’altronde, l’internamento rappresenta già di per sé una violenza enorme per la donna che perde ogni punto di riferimento e ogni possibilità di essere e di riconoscersi come individuo. Ci svegliavano di buon’ora alle cinque del mattino e ci allineavano su delle pancacce in uno stanzone orrendo che preludeva alla stanza degli elettroshock: così, ben presente potevamo avere la punizione che ci sarebbe toccata non appena avessimo sgarrato. Per tutto il giorno non ci facevano fare nulla, non ci davano né sigarette né cibo al di fuori del pranzo e della cena; e vietato era anche il parlare. I padiglioni erano ben divisi. Gli uomini stavano da una parte e le donne dall’altra. Le notti, per noi malati, erano particolarmente dolorose. Grida, invettive, sussulti strani, miagolii, come se si fosse in un connubio di streghe. I farmaci che ci propinavano erano o troppo tenui o sbagliati, per cui pochissime di noi riuscivano a dormire. Di giorno non facevamo nulla e, se la sera si era tentati di rimanere alzati un altro po’, subito venivamo redarguiti aspramente e mandati a letto con le «fascette».
Fascette? Di cosa si tratta?
Nient’altro che delle corde di grossa canapa, dentro le quali ci facevano infilare i piedi e le mani perché non potessimo scendere dai lettucci. Urlare sì, potevamo; nessuno ce lo impediva, tanto che qualche volta un malato a furia di urlare finiva col ricadere esangue sul suo letto. Ricordo di una paziente che rimase immersa nelle proprie feci urlando a squarciagola per giorni e giorni finché non venne slegata e rimandata in libertà. La poveretta, ovviamente, non sopportava quel genere di umiliazione.
Le è stato difficile adattarsi?
Dopo un po’ di tempo cominciai ad accettare quell’ambiente come buono, non mi rendevo conto che andavo incontro a quello strano fenomeno che gli psichiatri chiamano «spedalizzazione», per cui rifiuti il mondo esterno e cresci unicamente in un mondo esterno a te e a tutto il resto; mi ero fatta un concetto molto dolce, e cioè che io fossi un fiore e che crescessi in un’aiola deserta. La società per me era morta. Dal momento che mi aveva rifiutata e insediata tra quei rifiuti sociali non poteva e non doveva più esistere, e l’amore poi e la famiglia erano concetti che consideravo superati e triti. Tutto ciò era mera follia ma io non potevo rendermene conto, né, d’altra parte, mi si dava spazio perché io potessi modificare le mie idee.
E il personale dell’ospedale?
Beh, il dottor G. era un convinto freudiano e stabilì che se ero malata, qualcosa avrebbe dovuto aver turbato la mia infanzia. Ne convenni. Di fatto, ricordavo una infanzia vissuta in modo angoscioso, piena di tribolazioni interiori, con un morboso attaccamento alla madre. Perciò il dottor G. ritenne opportuno farmi fare due o tre elettroshock, anche perché nel frattempo ero caduta in un grave stato confusionale. Di fatto, dopo la shockterapia la mia mente divenne più elastica e cominciai a raccontare con un respiro più adeguato e coerente. Raccontai di tutto, della mia infanzia, del mio amore per i maschietti. Ricordo che mi chiese: «Non ricordate di essere stata violentata, vituperata da qualcuno?». Di fatto un buco nero nella mia memoria c’era, era dunque il punto malato. Sotto narcosi il mio comportamento era altamente negativo e gridavo come un’ossessa in preda ai più grossi deliri. Le nostre infermiere erano esseri privi di qualsiasi sentimento umano, almeno per quanto ci riguardava, e ci rendevano la vita ancora più nera mortificandoci e dandoci a vedere ad ogni piè sospinto che noi eravamo «diverse» e che quindi non potevamo entrare né nei loro discorsi, né nel loro genere di vita. La «Capa» era un vero mostro di scelleratezza. Dotata di eccezionale bellezza ma si divertiva a vedere soffrire i pazienti sotto l’effetto delle più forti terapie.
Prima parlava di umiliazioni, oltre agli elettroshock, a cos’altro si riferiva?
Al principio del ’65 quando ancora le leggi erano molto restrittive, ai malati era consentito così poco che nemmeno gli si dava la libertà di lavarsi. Ci allineavano davanti a un lavello comune con i piedi nudi fissi nelle pozzanghere d’acqua. Poi ci strappavano di fisso i pochi indumenti e poi le infermiere passavano a insaponarci anche nelle parti intime, e ci asciugavano in un comune lenzuolo lercio. Poi ci allineavano su delle pancarelle sordide e lì stavamo a guardare per terra come delle colpevoli, ammazzate dall’indifferenza, senza una parola, un sorriso, un dialogo qualunque. La prima volta che dovetti sottostare a questa rigida disciplina svenni. Il bagno di forza, o bagno di pena, era una delle cose che brillava nel nostro istituto.
Ricorda cosa pensava in quei momenti bui?
Io avevo sete di verità e non capivo come ero potuta capitare in quell’inferno. Il demente era considerato «incapace di intendere e di volere». Eppure, sotto la diagnosi serpeggiava quieta la mia anima dolce, rasserenante, un’anima che non era stata mai tanto luminosa e vitale.
In questo contesto, come ha vissuto il suo essere madre?
Beh, innanzitutto con il tempo cominciarono a darci dei permessi. Fu proprio durante una di queste visite a casa che io rimasi incinta. Ne fui contenta. Naturalmente non mi rendevo conto di quale grosso guaio mi stava capitando, ma ero contenta per una cosa: di fatto in gravidanza tutti i miei sintomi scomparivano e tornavo a essere una persona normale. Furono quasi sospese tutte le terapie e, cessate le mestruazioni, io non avevo più attacchi isterici. Rimasi quindi a casa nove mesi filati, senza dare alcun segno di stanchezza o decadimento psichico. Ma quando generai la mia piccola precipitai nuovamente nel caos e dovetti essere ricoverata ancora e la bambina affidata ad altri. Nella mia mente malata i figli dovevano necessariamente far parte del mio corpo, del mio io. Finché i miei figli li portavo in grembo, tutto poteva rientrare nella normalità, ma una volta che li mettevo al mondo mi riallacciavo inequivocabilmente al mito di Cronos che divorava la propria progenie. La morale era che i figli li dovevo affidare ad altri, perché mi facevano insorgere paurose allucinazioni e la cosa mi sgomentava. Quando rimasi incinta per la quarta volta sentii che qualche cosa si sarebbe definitivamente guastata dentro di me. Quella gravidanza era sommamente rischiosa. Passai quei nove mesi in uno stato generale di depressione. Il bimbo non doveva nascere bene, secondo me. Ma ormai non aspiravo più a nulla. Ma quando finalmente venne alla luce, io volevo prendere tra le braccia quella creatura e baciarmela e poterle dimostrare la mia gratitudine per essere ancora viva dopo tante peripezie, ma me la levarono subito di torno e mi riportarono alla clinica. Per parecchio tempo della bambina non seppi più nulla, finché un giorno entrai di botto dal primario e l’apostrofai così: «O mi date mia figlia o io vi ammazzo». Fu quella, credo, la prima volta che impazzii davvero.
C’è qualche aneddoto della vita manicomiale che vuole raccontarci?
Ce ne sono innumerevoli ma ricordo che una volta io, Alda Merini, rubai un paio di ciabatte e queste ciabatte diventarono lo scandalo dell’ospedale. Da allora venni chiamata ladra, di fronte a tutti e questo per diversi mesi. E fui segregata in uno stanzino di sicurezza perché non rubassi più. Quelle ciabatte mi ricordavano le ciabatte di mia madre, di cui tanto sentivo il bisogno. Non ero quindi ladra, e venni liberata. Ma per quelle ciabatte subii un vero e proprio interrogatorio.
Da tutta questa esperienza, traumatica se mi permette di aggiungere, cosa ha imparato? Cosa direbbe alle nuove e alle vecchie generazioni?
Il manicomio non è correzionale. Ognuno che vi entra porta i suoi valori sostanziali e ve li conserva gelosamente. Così ho fatto io, a dispetto di tutti i vituperi e di tutti gli elettroshock. L’uomo è socialmente cattivo, un cattivo soggetto. E quando trova una tortora, qualcuno che parla troppo piano, qualcuno che piange, gli butta addosso le proprie colpe, e così nascono i pazzi. Perché la pazzia, amici miei, non esiste. Esiste soltanto nei riflessi onirici del sonno e in quel terrore che abbiamo tutti, inveterato, di perdere la nostra ragione.
A cura di Cristina Stabile