Il racconto della domenica: Diversi di Paolo Leibanti
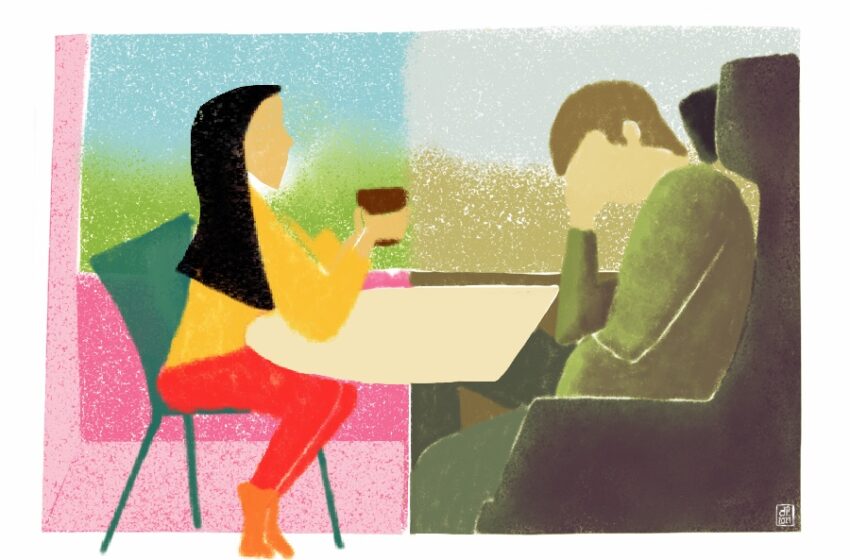
Illustrazione di Francesca Galli
Ho scoperto, studiando l’ebraico biblico,
che la traduzione corretta di Lv 19,18 non è
“ama il prossimo tuo come te stesso”, ma
“amare il prossimo tuo è te stesso”.
(Lettera di Francesca del 10 luglio 1996)
Alla fine incontrai Francesca solo quella volta. Era venuta a Padova a trovare un amico – lei era piena di amici – e aveva deciso che dovevamo vederci.
Anche se non ci eravamo mai visti, io e Francesca ci conoscevamo bene per via delle lettere – le e-mail ancora non c’erano. Io scrivevo da Trebaseleghe e lei da Roma: ci voleva una settimana perché una lettera andasse da una parte all’altra. Quando arrivava, uno scriveva subito la sua risposta e così via. Era bello aspettare una lettera, era come ricevere un regalo. Non sapevi mai cosa c’era dentro. Almeno all’inizio.
Una rivista, Storie si chiamava, mi aveva pubblicato un raccontino intitolato Il primo, nel quale un uomo lasciava un posto bellissimo per non rinunciare a stare con l’amata, e quest’uomo sarebbe stato Adamo. Uno scherzo di racconto, ma Francesca l’aveva letto e l’aveva preso sul serio. Lei studiava Filosofia e stava preparando la tesi con la cattedra di Teologia Ebraica. Così aveva contattato la redazione di Storie e, siccome non c’era la legge sulla privacy, le avevano dato il mio indirizzo. Mi aveva scritto interpretando la mia storiella ben oltre le mie intenzioni, citando pericopi evangeliche e brani del Talmud. Le avevo risposto spiegandole la mia più modesta ispirazione, e la storia di scriverci, lettera dopo lettera, andò avanti. Avevamo alcune cose in comune, come l’antiberlusconismo e la passione per il cinema di Nanni Moretti, ma per il resto le nostre vite erano diversissime. Lei a Roma aveva occasione di seguire corsi serali di lingua portoghese, di andare a concerti di musica classica, di fare volontariato con i disabili, di partecipare a manifestazioni per i diritti umani. A Trebaseleghe invece l’offerta culturale e ricreativa, se così si può dire, era molto più povera, e peraltro quella poca nemmeno incontrava il mio interesse. Nelle sue lettere Francesca mi raccontava anche i suoi fatti privati, tipo litigi con la madre e pianti in solitudine, ma questa cosa non mi piaceva tanto. Comunque c’era da imparare un sacco attraverso quello che mi scriveva, mi nominava scrittori e filosofi di cui non avevo mai sentito parlare prima, tipo Martin Buber o Wisława Szymborska.
Quando fissammo l’appuntamento alla stazione di Padova era novembre. Ci scrivevamo da giugno, e io già mi ero stancato. In sei mesi Francesca mi aveva inviato una dozzina di lettere di quattro-cinque pagine ciascuna scritte a mano, fitte fitte, per un totale di cinquanta fogli che non ci stavano nemmeno più dentro alla scatola in cui li tenevo. Era impossibile starle dietro, con tutti quei suoi filosofi e filantropi e teologi e pensatori e poeti. Risponderle era diventata una faticaccia, così avevo deciso di chiudere. Quell’appuntamento a Padova sarebbe stata l’occasione giusta per dirglielo di persona, da bravo ragazzo maturo.
Come promesso, mi aspettava davanti al negozio di bigiotteria della stazione. Non c’erano dubbi che fosse lei, era uguale alla foto che mi aveva spedito: i capelli neri lunghi, le guance paffutelle, il sorriso sottile. Anche lei mi riconobbe subito, e mi fece un cenno. Mi aspettavo di doverla salutare con una stretta di mano, invece quando mi fu vicina mi abbracciò. Era una bella spanna più bassa di me, così mi ritrovai la sua testa sotto la faccia. I suoi capelli profumavano di frutta. Poco lontano da noi, davanti alla bacheca degli arrivi, un giovane con zaino e giubbetto di pelle e una ragazza dai capelli biondi si baciavano con gli occhi chiusi, come non ci fosse nessuno.
Quando mi liberò dall’abbraccio, Francesca mi fissò e disse che ero uguale al Paolo della fotografia, poi mi prese sottobraccio e mi accompagnò fuori dalla stazione. Iniziammo a conversare parlando del tempo autunnale e di come avevamo cominciato la giornata, lei nella sua camera d’albergo a due stelle con la persiana che si chiudeva male, io svegliato dal baccano di mia nonna che aveva rotto una tazza in cucina. Anche se mi sembrava che in ogni parola che dicevo ci fosse l’ombra di quello che avevo intenzione di dirle sul nostro rapporto, non avevo voglia di affrontare subito l’argomento.
Il cielo sopra di noi era nuvoloso, ma non in modo compatto, alcuni minuti di nuvolo si alternavano ad altri di sole. Francesca conosceva Padova meglio di me, e mi condusse in un piccolo bar, lungo una strada secondaria. Un posto alternativo, c’era scritto sull’insegna fuori, ma dentro non manteneva la promessa. C’erano odore di caffè, rumore di tazzine, tre tavoli occupati e una copia del Gazzettino abbandonata sopra a una mensola. Ci accomodammo uno di fronte all’altro, su un tavolino quadrato addossato a una vetrata. Subito si avvicinò una ragazza in grembiule bordeaux, e ordinammo cappuccino e brioche.
La cameriera si era appena allontanata che Francesca riprese a tediarmi raccontandomi del suo più o meno ragazzo, un certo Luca Beltenebroso, un fotografo freelance appena tornato dalla Serbia che aveva voluto presentarmi nell’ultima lettera. Gli era scoppiata una mina antiuomo a qualche metro di distanza, poveraccio. Ma non si era fatto niente, comunque, quello che aveva perso la gamba era stato il contadino che camminava davanti a lui. Io ogni tanto annuivo, e nel frattempo giocavo a fare pieghe sulle bustine dello zucchero. Mi era anche venuta voglia di sfogliare il Gazzettino, ma era troppo lontano e avrei dovuto alzarmi.
Quando tornò la ragazza delle ordinazioni con le brioche e i cappuccini, Francesca mi stava confidando come le cose con Luca andassero male. Secondo lei, lui aveva un qualche disturbo della personalità, era sempre più chiuso ed egocentrico, non le raccontava più niente, e se non lo chiamava lei, lui non la cercava mai, e quando andava a trovarlo lui continuava a leggere i suoi Dylan Dog e nemmeno la ascoltava. Mentre parlava, io sbocconcellavo la mia brioche e lanciavo qualche occhiata alle gambe della cameriera che girava per i tavoli. Finalmente concluse che ormai non lo sopportava proprio più, quel Luca, e che era sempre più difficile starci insieme. Bene, dissi io masticando, allora che soffri a fare, lascialo perdere, no?
Avrei potuto prendere ispirazione dalle stranezze di Luca per dirle che anche lei però non era una semplice, e introdurre così tutto il discorso che mi ero preparato. Avrei potuto ricordarle, per esempio, che quella volta in cui le avevo chiesto di elencare dieci cose che le piacevano, lei mi aveva scritto le dieci cose di cui aveva paura, tra cui c’erano la guerra e le malattie, ma anche le bambole di ceramica e i parchi bui, e che le cose belle me le aveva elencate solo in una lettera successiva, ma tra le prime della lista c’erano vestirsi da pagliaccio per far ridere i bambini malati e imparare l’ebraico biblico, che saranno anche state cose belle, ma cavolo sembravano uscite dalla lista di una cinquantenne, e io non credevo di aver bisogno della corrispondenza con una cinquantenne. Ci potevano star bene da snocciolare a quel punto, tutte queste osservazioni, ma alla fine le dissi soltanto lascialo perdere.
Terminati i discorsi sui suoi problemi sentimentali, Francesca mi chiese dei miei colloqui di lavoro, e io mi lagnai di come finisse sempre che avevo qualcosa che non andava: non avevo conseguito un master a Yale o a Harvard, non avevo fatto esperienza in nessuna multinazionale, non conoscevo il cantonese, oppure in altri casi ero troppo qualificato. Abbastanza deprimente, per un neolaureato in Economia che invece avrebbe avuto voglia di scaricare tutto il suo entusiasmo in un qualche impiego per guadagnarsi le sue prime lirette. Una situazione che mi stava mandando un po’ in crisi, riconobbi. E con l’occasione sfoggiai Gramsci: la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Lei disse, quasi agitandosi, che mi sentiva passivo, rassegnato. Dovevo essere più determinato, anche disposto a lasciare il mio villaggio di campagna, come lo chiamava lei. Mentre mi scolavo l’ultimo goccio di cappuccino per godermi i cristalli di zucchero rimasti sul fondo della tazzina, mi ricordò la storia del Talmud secondo cui l’umile sta un gradino sotto Dio, ma chi si compatisce deve ancora cominciare l’ascesa della scala, e il George Gray di Edgar Lee Masters, quello dell’Antologia di Spoon River della nave ferma nel porto senza le vele eccetera eccetera. Deve aver detto anche molte altre cose sensate, ma le ho dimenticate.
Per non parlare troppo di me, o almeno per non parlare troppo di me in quel modo, le chiesi della sua tesi, e lei mi disse di qualche difficoltà col suo professore di Morale-e-qualcosa. Io dissi che non ero capace di preoccuparmi per una laureanda in filosofia con la media del trenta e che alla fine del terzo anno aveva già sostenuto anche tutti gli esami del quarto. Anzi, a una così i comuni mortali gliel’auguravano, qualche difficoltà. Per qualche secondo un fascio di sole filtrò tra le nuvole e tra i palazzi, e la sorprese con i gomiti appoggiati sul tavolo e il viso tra le mani. Io invece ero seduto sbilenco, con le gambe accavallate e un braccio che penzolava dietro allo schienale della sedia. Il tempo di volgere lo sguardo fuori, e il sole se n’era già andato.
Ci alzammo, e volle pagare lei: era stato suo l’invito. Nel percorso di ritorno verso la stazione, mi prese ancora sottobraccio e mi disse che venerdì tornava a Roma, perché sabato mattina aveva il turno di volontariato al reparto di pediatria dell’ospedale, e al pomeriggio voleva partecipare a una conferenza sul senso di Dio nella letteratura di fantascienza. Io le dissi invece che i miei programmi per sabato erano nel pomeriggio andare a giocare a calcio con gli amici, e alla sera uscire a bermi una birra non prima di aver terminato di guardare la videocassetta con i primi tre episodi di Daitarn III che avevo acquistato in edicola. Non ero sicuro di come l’avrebbe presa, ma la prese bene, per fortuna. Rise, e diventava quasi carina, quando rideva.
Verso la fine di Corso del Popolo ci tenne a dirmi che nella lettera che mi stava scrivendo avrebbe anche commentato la mia osservazione secondo cui chi sceglie la solitudine ha il merito di lasciare un po’ più soli tutti gli altri. Io cercai di spiegarle che la mia era solo una provocazione a sostegno del suo elogio del silenzio, ma lei come al solito voleva approfondire. Ecco un’altra cosa che cominciavo a trovare insopportabile di Francesca: prendeva sempre tutto maledettamente sul serio.
Stavo provando a dirglielo, e poteva essere un’altra occasione buona per partire con il mio fatidico discorso di addio, quando all’entrata in stazione fummo sorpresi da un rumore frenetico, un picchiettare secco e continuo come di rotativa, un tic-tic-tic-tic-tic velocissimo. Alzando lo sguardo scoprimmo che si trattava del grande tabellone delle partenze sopra alla biglietteria: era impazzito. Le tessere nere delle destinazioni, di tutta la colonna delle destinazioni, non si fermavano per comporre i nomi delle città, ma ruotavano senza sosta. Sotto al frullio meccanico del tabellone stava crescendo anche il brusio prodotto dai viaggiatori nel salone, che si accalcavano davanti alle biglietterie e alle bacheche con i poster di “Partenze” e “Arrivi”. Fingendomi allarmato, dissi che a causa di quel guasto anche io rischiavo di non riuscire più a tornare a casa, e magari di finire per sbaglio a Roma. In verità, ben sapevo l’orario e il binario del treno per Bassano che dovevo prendere.
Era già arrivato il momento di separarci e io ancora non le avevo detto niente. Lei mi ringraziava per la mattinata insieme e io la fissavo come non avevo ancora fatto in quelle ore. La guardavo cercando il coraggio di parlarle della mia decisione. Magari bastava solo cominciare. «Francesca», provai, «siamo così… diversi». Siamo così diversi? Non erano quelle le parole che avevo preparato. In tutte le simulazioni che avevo fatto del discorso di addio non avevo mai iniziato con parole così tristi. Lei mi guardò, alzò le spalle e disse: «Lo so, è questo il bello». Al solito, lei sapeva sempre tutto. Ma io non ero convinto che fosse quello il bello, anzi, mi sembrava proprio una risposta del cavolo. Comunque, la bolla di ansia da ultima possibilità che mi stava crescendo dentro a quel punto scoppiò, e seppi che non le avrei più detto niente. Francesca si protese verso di me per darmi un bacio sulla guancia, e insieme alle sue labbra asciutte sulla pelle risentii il profumo fruttato dei suoi capelli. «Sono felice di averti come amico,» mi sussurrò. Forse era disposta ad abbracciarmi, ma io mi staccai e tesi la mano. Me la strinse con le sue piccole dita per alcuni secondi, mi salutò con un ciao e si avviò verso l’uscita. Mentre mi dirigevo verso il sottopassaggio per i binari, mi chiedevo se l’avrei più rivista.
Arrivai al binario 10 che il treno che mi doveva portare a Camposampiero ancora non c’era. Sulla banchina trovai il ragazzo con lo zaino e il giubbetto di pelle, quello che qualche ora prima baciava la ragazza bionda davanti agli arrivi. Adesso era solo anche lui. Era alto e magro più o meno come me. Aveva un walkman con le cuffiette, e teneva la musica a un volume così alto che riuscii a distinguere quello che stava ascoltando: i Depeche Mode. All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms.
Mi sembrava simpatico, così cominciai a parlargli. Mi ero tenuto a un paio di metri di distanza, e fissavo come lui le bottigliette di plastica schiacciate e i fazzoletti di carta sporchi abbandonati tra le rotaie davanti a noi. Gli dissi che a Francesca alla fine gliel’avrei scritto della mia decisione, perché per lettera mi spiegavo meglio. Le avrei scritto per l’ultima volta dicendole che rinunciavo alla nostra corrispondenza perché mi ero aspettato che quelle lettere mi avrebbero aiutato di più. Poi gli dissi che avrei dovuto essere contento che Francesca mi avesse definito suo amico, ma non riuscivo a esserlo. A quel punto il ragazzo si accorse che gli stavo parlando, si sollevò la cuffia dall’orecchio sinistro e voltandosi mi chiese se avevo bisogno di qualcosa. Io annuii, e gli sussurrai che non riuscivo a essere contento perché lei era piena di amici, e invece le persone importanti non possono essere tante. Lui sgranò gli occhi, io gli diedi una pacca sulla sua spalla di pelle nera e mi allontanai lungo la banchina.
Mi fermai una ventina di passi più avanti. Mi scosse un brivido di freddo, così alzai la zip del giubbotto fin sotto il mento. Mi attendeva un viaggio di ritorno attaccato al finestrino a guardare salici e granturco secco. Estrassi il biglietto dal portafoglio e lo infilai nella fessura dell’obliteratrice. Il timbro impresse 11.47, e il treno sarebbe partito alle 11.55. Ero in anticipo, come sempre. Io non ho mai perso un treno. Di quelli per tornare a casa.
Paolo Leibanti

















