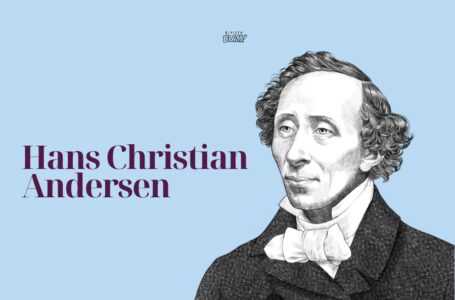Ritratti di scrittori: Cesare Pavese, chi era? Scoprilo in 5 parole

Ritratto illustrato di Sonia De Nardo
Saggista, romanziere, instancabile editore, giornalista: Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 1908 – Torino, 1950) era tutto questo e – decisamente – molto altro. Con il suo esordio, Paesi tuoi, inaugurò una delle più importanti collane di Einaudi, i Narratori contemporanei, e di Einaudi fu anche il direttore durante gli anni terribili della guerra. Lavorò con Natalia Ginzburg, Giulio Einaudi, Elio Vittorini; fu lui a scoprire Italo Calvino, che lo considerò, fino alla fine, un maestro. Cesare Pavese non era certo un uomo facile: la Ginzburg, nel suo commovente Ritratto di un amico, lo tratteggia come una persona riservata, un po’ scontrosa, laconica. Eppure, nei suoi libri si concesse come pochi altri, raccontando una vita fatta di terra e sangue, vizi assurdi e sogni falliti. Senza ombra di dubbio, Pavese è uno degli scrittori più umani che abbiamo avuto la fortuna di leggere. E, non a caso, è anche uno dei più amati.
Cesare Pavese: chi era lo scrittore in 5 parole
Campagna
Quando Cesare Pavese nacque, i suoi genitori si trovavano nella casa delle vacanze estive, in un paesino sperduto delle Langhe che portava il nome di un santo e di un fiumiciattolo: Santo Stefano Belbo. In quel paesino, Pavese avrebbe trascorso i momenti più belli della sua infanzia e adolescenza: le passeggiate con gli amici, le gare a rincorrersi, le feste di paese, i giorni in cui si assaggiava il vino appena fermentato. La campagna sarebbe diventata, naturalmente, un luogo di elezione, un posto magico che acquistava le sembianze di una patria idilliaca perduta, quando era il tempo di tornare in città. Era lì che si nascondevano i misteri dell’esistenza, i nuclei antichi delle cose – e di notte, quando si stava sdraiati sull’erba, in silenzio, sembrava quasi di sentirli e vederli, questi misteri, nella magia dei falò che illuminavano la collina. La terra di Pavese è antica, è maestra, è madre e donna: è il nucleo da cui derivano la vita e la morte. Ma è anche sangue, vino, carne che pulsa e nasconde la violenza dei ritmi antichi, delle ceneri e dei sacrifici. In tutti i suoi scritti, la campagna ritorna come un’immagine ossessiva – a partire dal primo libro pubblicato, Paesi tuoi, dove la terra si lega al ritmo antico della morte, fino all’ultimo romanzo, La luna e i falò, nel quale le Langhe diventano patria perduta e riconquistata, ancora una volta, nel segno della perdita.
America
Non è un caso, allora, che Cesare Pavese fosse legato così tanto all’America – il luogo che, nell’immaginario comune, rappresenta la terra selvaggia per eccellenza. Pavese si occupò di letteratura americana sin dalla sua tesi di laurea, che era dedicata a Walt Whitman, e continuò per tutta la vita. A lui si devono le prime traduzioni di alcuni dei libri più importanti di quella letteratura: Uomini e topi di John Steinbeck, per esempio, o, ancora, Moby Dick di Herman Melville. Questo impegno, quasi scontato negli anni che viviamo, aveva un senso totalmente diverso all’epoca di Pavese. Negli anni ’30 e ’40 l’Italia si era completamente tagliata fuori da qualsiasi tipo di comunicazione internazionale. La cultura ne aveva risentito moltissimo, diventando provinciale e stagnante. Fu proprio Cesare Pavese, insieme a molti altri intellettuali che bazzicavano gli ambienti einaudiani, a rendere l’altro materia di interesse e pubblicazione. Einaudi diede vita, in quegli anni, a traduzioni, saggistica e collane specifiche – e se oggi esiste un mito dell’America, lo dobbiamo anche a lui.
Mito
Mito: forse il senso di tutto il lavoro di Cesare Pavese potrebbe racchiudersi in queste quattro lettere che vengono da lontano. Il mito è la matrice, il nucleo atavico e fuori dal tempo da cui discende l’umano, il possibile, il destino. E Pavese ne era completamente ossessionato. In ogni suo libro, anche quando non viene esplicitamente tematizzato, si riconosce il senso di una vicenda umana unica e irripetibile. C’è nelle poesie di Lavorare stanca – dove spunta, tra le pagine, un titolo quanto mai parlante: Il dio caprone; c’è ne La luna e i falò, in quei ritmi atavici del fuoco e della fecondazione, della morte e della vita; c’è nei Dialoghi con Leucò, la raccolta in cui sono proprio i personaggi dei miti antichi a prendere la parola. Il 27 agosto 1950, quando Pavese mise fine alla propria vita, fu esattamente quest’ultimo il libro su cui decise di annotare un messaggio d’addio – breve, affilato, laconico: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi». I Dialoghi diventarono il suo testamento, il suo ultimo lascito, la summa del suo pensiero – e il mito, dal canto suo, il sigillo di una ricerca «insaziabile».
Amore
In una lettera a Romilda Bollati, si legge: «Posso dirti, amore, che non mi sono mai svegliato con una donna mia al fianco, che chi ho amato non mi ha mai preso sul serio, e che ignoro lo sguardo di riconoscenza che una donna rivolge a un uomo?». Queste parole, laceranti, sintetizzavano una vita di aneliti insoddisfatti, di legami marci e inconcludenti. Cesare Pavese aveva cercato l’amore disperatamente, aggrappandosi a tutte le donne che aveva conosciuto quasi ne dipendesse la sua intera esistenza. Viveva di sogni, di attese febbrili e ingenue, come un innamorato adolescente – e fa sorridere sorprenderlo, tra le righe delle sue poesie più intime, quasi intimidito dallo sguardo sorridente di una ballerina. L’amore di Pavese era un amore spinoso, impulsivo, fatto di sangue e carne: «Sangue di primavera / – anemone o nube – / il tuo passo leggero / ha violato la terra. / Ricomincia il dolore». Ed è un amore sinistro, avvelenato, in cui si scorgono i segni della fine: «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi».
Morte
Questa fine, questa morte ossessiva, Pavese l’aveva sentita fin da un giorno tenebroso dei suoi diciotto anni. Era un destino, un «vizio assurdo»: un pensiero martellante attorno a cui si arrovellano pagine e pagine del suo diario. Pavese era convinto che qualsiasi essere umano avesse un destino, inscritto nella pelle, marchiato sul corpo: «nessuno può sfuggire al destino che l’ha segnato dalla nascita col fuoco» (Dialoghi con Leucò). Il suo era il suicidio, il «gesto», quello che avrebbe messo fine a tutte le parole che negli anni aveva scritto, forse, come una purga: «Nessuno si uccide. La morte è destino». Quella morte aveva cercato di indovinarla spesso, negli anni e nei mesi precedenti. Aveva scritto un apologo, poi un romanzo che presagiva – con dovizia di particolari – il modo in cui sarebbe avvenuto: Tra donne sole, un testo dilaniante e soffocante, in cui l’epilogo si intravede già dalle prime pagine, quando una donna prova ad uccidersi in una stanza d’albergo. Le pagine del diario precedenti a quel terribile 27 agosto 1950 sono sofferte, piene di dubbi e di incertezze, di anime che si dibattono e tentano di trovare uno spiraglio di luce. La vita di Pavese si concluse in solitudine, in un luogo anonimo e in una calda giornata d’estate in cui nessuno avrebbe potuto impedirglielo. Non c’erano i suoi amici di sempre, non c’era sua sorella, né la sua amata Constance. L’aveva cercata, aveva forse sperato di trovare in lei un appiglio – ma alla fine la sua assenza non era stata niente di più che una conferma: «Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualsiasi amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla» (Il mestiere di vivere).
Cesare Pavese: i libri da leggere per approcciare a questo scrittore
- Dialoghi con Leucò, Einaudi, 1947 (raccolta di racconti)
- La casa in collina, Einaudi, 1948 (romanzo)
- La bella estate, Einaudi, 1949 (trilogia di romanzi)
- La luna e i falò, Einaudi, 1950 (romanzo)
- Poesie, Einaudi (volume onnicomprensivo)
a cura di Rebecca Molea