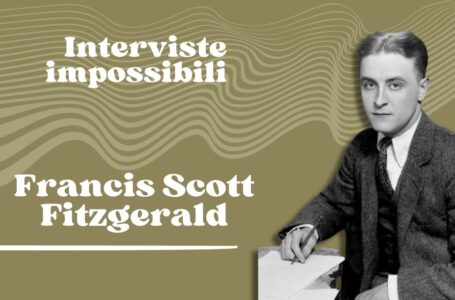Nicola H. Cosentino, ritratto di uno scrittore trentenne tra musica e nostalgia. Intervista

Nicola H. Cosentino è l’autore del romanzo Le tracce fantasma, pubblicato da minimum fax lo scorso settembre. Scrittore, critico, collaboratore di «la Lettura» del «Corriere della Sera», Cosentino appartiene alla schiera degli autori nati negli anni Novanta e che, con una buona dose di cinismo, disillusione ma anche romanticismo, si sta facendo largo nell’editoria italiana. Poco più che trentenne, è il rappresentante di una generazione che dell’amarcord sembra aver fatto una bandiera. Non è certo un caso che a ogni presentazione del suo libro faccia capolino un gruppo di nostalgici della musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta pronto a chiedere all’autore cosa ne pensa di quella che viene considerata la moda del momento: la trap. Lo abbiamo intervistato per voi.
Buona lettura!
Cosa significa per uno scrittore aver vissuto l’infanzia negli anni Novanta e l’adolescenza nei Duemila?
La mia è una generazione che si trova molto a proprio agio con il romanzo, nello scriverlo e nel leggerlo, perché è naturalmente legato al passato remoto che è il tempo della narrazione borghese. Siamo cresciuti in un periodo che sembrava ci avrebbe condotto verso un futuro radioso, pieno di successi e di benessere economico e invece ci siamo trovati davanti a una costante regressione. Noi abbiamo già un ottimo rapporto con la memoria, con la nostalgia. Gran parte dell’arte che produciamo fa riferimento alla rievocazione e all’amore per le cose che non ci sono più. Questa fine del sogno, che non ci aspettavamo, ci permette di raccontare storie sulla disillusione ma anche storie che vorrebbero essere piene di felicità e di romanticismo. Mi sembra che questa sia la strada verso cui ci stiamo incamminando tutti ed è una staffetta che stiamo lasciando alla generazione successiva, quella degli adolescenti di oggi. È come togliersi un’armatura e ammettere che a noi non è andata poi così bene ma non vediamo l’ora che il futuro sia più libero, più romantico, più allegro.
Il protagonista del tuo ultimo romanzo, Valerio, si trova a suo agio con questa malinconia ma è al tempo stesso un personaggio cinico, ironico. È il simbolo di questa generazione?
Valerio è l’estremizzazione di una generazione che non è propriamente la mia perché ha dieci anni più di me. Per raccontare questa esasperazione però avevo bisogno di qualcuno che ritenesse i suoi giochi già fatti, di una figura che fosse più nostalgica di me nei confronti degli stessi anni in cui io sono nato e che ricordo più che altro perché mi sono stati raccontati. Valerio è l’emblema dell’allontanamento dalla retorica del successo e del «deve andare bene a tutti i costi» a cui ci hanno abituato. La sua è una storia di deformazione perché si accorge a un certo punto di dover rompere il guscio del suo cinismo per aprirsi al mondo, per accettare la propria debolezza, per vedere il bello che ha intorno.
Quello dell’adolescenza è un tema molto presente all’interno del libro ma a parlarne è Valerio che è un quasi quarantenne. Come mai?
In primis perché era l’unico modo per poterla raccontare volendo descrivere la giovinezza vista col senno di poi. All’interno del romanzo ci sono tanti tipi di adolescenza e il tema è effettivamente centrale perché è proprio questo il motivo per cui scriviamo noi che scriviamo e per cui leggiamo noi che leggiamo. Tutti vorremmo cercare di dare un senso a quel caos emotivo che abbiamo iniziato a registrare quando eravamo ragazzini. È inevitabile tornare sempre a quella fase della nostra vita ma al tempo stesso abbiamo una certa difficoltà a raccontarla perché quando lo facciamo non siamo più degli adolescenti. Tutti pensiamo in continuazione a quell’epoca che è quindi l’emblema della nostalgia. È la frustrazione di voler raccontare una cosa che iniziamo a capire solo quando non siamo più in grado di viverla. E poi far raccontare l’adolescenza da Valerio è un espediente per fare un confronto tra le generazioni: i sentimenti si esprimono anche attraverso i contenuti culturali, come le canzoni. Da qui nasce anche la difficoltà a dialogare tra generazioni diverse.
Valerio rischia di essere schiacciato dalla passione per la musica. Può accadere nella vita vera?
Dipende da come si vive il rapporto con l’arte. Quello che ho io è diverso da quello del protagonista. Come tutte le passioni, anche la musica, se si vuole possederla per avvicinarsi alle proprie ambizioni, può ferire, se invece la si vive passivamente, senza creare, ci insegna a essere empatici e a soffrire ma ci cura al tempo stesso, addolcisce delle esperienze che abbiamo vissuto. Questo è comunque un romanzo puramente di fiction, io e Valerio siamo molto diversi anche se ci accomuna la conoscenza dei luoghi e degli ambienti culturali. Il protagonista fa il critico probabilmente perché è un mestiere che io conosco molto bene e chiunque lavori in ambito culturale sa che questo genere di lavoro ben si sposa con la frustrazione perché non ha un grande spazio nell’economia. Valerio estremizza questa sensazione. L’industria culturale oggi è piena di dispiacere per come dovrebbe essere e per come non è.
Nel romanzo però non c’è solo Valerio che non è riuscito a sfondare nel campo della musica, ma anche Giacomo che invece ce l’ha fatta…
Dipende da cosa intendiamo per successo, per me l’importante è dare un senso alla propria vita. Nel romanzo si parla del tema del decostruire la propria ambizione, del porsi la domanda: «Ok, lui ce l’ha fatta mentre io non sono diventato nessuno e quindi?». In un’epoca in cui ci hanno fatto credere che saremmo potuti diventare chi avremmo voluto questo diventa un problema molto interessante. Non riuscire a emergere per chi ha sfiorato la possibilità di farlo è drammatico. A me ha sempre incuriosito questo tema e per questo sono riuscito a relativizzarlo, a sfidare questa sorte che impone di avere sempre successo, a dire che tutto sommato non è necessario.
Nicola H. Cosentino e la musica. Che rapporto c’è?
La mia è una passione non dichiarata, molte delle persone che hanno lavorato con me in questi anni non sospettavano nulla. Sono un ascoltatore onnivoro, anche un po’ ingenuo, sento di tutto, non ho nessun tipo di preconcetto, è la passione più libera che ho. Ho costruito il gusto di Valerio anche sul mio, ho pescato tra le cose che mi piacciono. Ascolto tanta musica per scrivere. In realtà la ascolto prima di scrivere, per immaginare, non mentre scrivo altrimenti non riuscirei a produrre niente. Questo libro è anche un modo per dichiarare il mio amore per cose di cui in genere non parlo, come l’influenza di alcuni cantautori o di alcune frasi che per me sono molto importanti. Quella per Ivan Graziani ad esempio è una specie di dichiarazione d’amore, ho voluto che nel romanzo ci fossero proprio le sue canzoni.
Delle persone che abbiamo intorno spesso non conosciamo molti aspetti. È un bene o un male che queste tracce restino fantasma?
Il finale del libro in effetti fa venire il dubbio. Io penso che la fantasia ci permetta di dare senso al mondo che viviamo che è un mondo senza magia. È meglio quindi non sapere tutto. È possibile apprezzare davvero il valore delle cose quando ci sono state ben nascoste, sono state scartate. Noi ci formiamo con l’abbandono. Il valore del prodotto finale è dato da ciò che tagliamo fuori, da quel che non c’è. La versione degli altri che ci arriva, quella senza tracce fantasma, è quella riveduta e corretta ed è l’unica versione possibile. Il resto sono elementi ritenuti trascurabili, nascosti. La versione giusta è quella che scegliamo di presentare. È proprio questo in fondo che ci insegna il romanzo che è il genere letterario più riveduto e corretto in assoluto.
A cura di Barbara Rossi