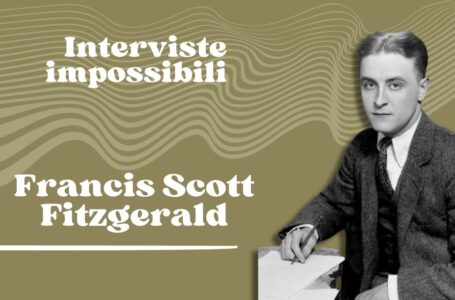Nadeesha Uyangoda: intervista alla scrittrice di L’unica persona nera nella stanza

Quando l’abbiamo intervistata, Nadeesha Uyangoda stava passeggiando per le vie di Milano, e se arriverete alla fine di questa conversazione scoprirete che è una delle cose che le piace più fare. A marzo scorso è uscito in libreria il suo primo lavoro per 66thand2nd, L’unica persona nera nella stanza, che racconta il tema dell’identità e della razza dal punto di vista delle seconde generazioni. Da anni fa la giornalista freelance per testate nazionali e internazionali, tra cui Vice Italia e Al Jazeera, e da poco ha esordito nel mondo del podcasting con Sulla Razza. Con lei abbiamo parlato di stereotipi, narrazioni e sogni coltivati da bambini. Buona lettura!
L’unica persona nera nella stanza è il tuo primo libro, anche se tu scrivi da moltissimo tempo come giornalista. La prima domanda che ti faccio, quindi, è: come sei arrivata alla pubblicazione? È stato difficile trovare l’editore giusto?
Inizialmente, il testo è nato come un longform che avevo scritto per Not un paio di anni fa. L’idea dell’articolo era venuta fuori da una serie di esperienze personali a cui avevo in parte accennato sui social. Quelle stories erano state lette anche da Violetta Bellocchio e lei mi aveva spinto a scriverci un articolo. Il pezzo ha avuto più successo di quanto mi aspettassi, perché, riflettendoci a posteriori, non erano mai usciti articoli sulla questione razziale in Italia scritti in prima persona dal punto di vista di una persona di minoranza etnica. Dopo qualche giorno dalla pubblicazione mi ha scritto Alessandro Gazoia, che poi poi sarebbe diventato il mio editor, perché aveva visto nell’articolo la possibilità di un libro e voleva chiedermi se avessi voglia di scriverlo. All’inizio sono stata un po’ titubante, perché sarebbe stato il mio primo libro e non ero sicura di essere pronta. Poi, però, mi sono confrontata con altre persone e ho deciso di provarci: così è nato L’unica persona nera nella stanza. Mi sono trovata molto bene con il mio editore, che è un indipendente: non credo che ci sarebbe stato un editore migliore per uscire con un libro del genere.
Effettivamente 66thand2nd è un editore molto impegnato verso questi argomenti, tanto che il suo catalogo ospita molte realtà diverse da quella italiana.
Sì, infatti. La casa editrice ha pubblicato libri in traduzione come Citizen di Claudia Rankine, che si occupa della questione razziale, e autori italiani come Cristina Ali Farah, che è un pilastro della letteratura decoloniale italiana.
Nel tuo libro parli spesso della difficoltà di essere rappresentati e di poter rappresentarsi. Gli spazi di discussione e quelli intellettuali tendono ad aprirsi poco, se non in occasioni sporadiche, alle persone di minoranza etnica. Quanto ha inciso ciò sul tuo percorso lavorativo da giornalista?
Come dico nel libro, molti giornalisti, aspiranti giornalisti e scrittori di seconda generazione spesso decidono di lavorare per l’estero. I motivi sono due. Da una parte, c’è una mancanza di inclusione nelle redazioni degli ambienti culturali e lavorativi italiani. Dall’altra, c’è una questione economica, perché le persone con un background migratorio non hanno legami forti con il paese in cui sono cresciute, nel senso che non hanno degli appoggi familiari, e di conseguenza non posseggono una casa di proprietà. Può sembrare un dettaglio banale, ma in realtà nel settore culturale questo diventa un problema, dato che i giovani sono pagati poco e non possono sostenere le spese di un affitto. All’estero la situazione è molto diversa, per cui tanti ragazzi di seconda generazione sono spinti verso quell’ambiente.
Qualche tempo fa, in un’intervista fatta con Irene Graziosi per Venti, dicevi che per molti ragazzi di minoranza etnica è quasi un obbligo affrontare il tema razziale, come se fosse un rito di passaggio. In quell’occasione hai aggiunto anche che in realtà a te piace questo ambito e sei felice di occupartene. C’è stato, però, un momento in cui l’hai percepito come un obbligo, una forzatura?
No, non penso di averlo mai avvertito come un passaggio obbligato, anche se mi è sembrato che gli altri si aspettassero da me che mi occupassi della tematica razziale. Io sono felice di coprire questo argomento perché mi piace, anche se ora avverto di essere arrivata al un punto in cui sono un po’ stanca di far vedere che faccio ciò che gli altri si aspettano da me. Mi piace ancora parlare della questione razziale, ma non ne ho più troppa voglia.
Cosa volevi fare da piccola? E come hai capito che avresti voluto lavorare con le parole?
Ho sempre avuto una propensione per la scrittura. Già da bambina dicevo che avrei fatto la scrittrice, era ciò che mi piaceva.
Torniamo a parlare di L’unica persona nera nella stanza: uno dei temi più rilevanti con cui il libro dialoga sono gli stereotipi, quelle scorciatoie mentali di cui il nostro cervello ha bisogno per interpretare in maniera più immediata il mondo. Secondo te, cosa differenzia lo stereotipo “fisiologico” da quello lesivo, come quello razziale? Che tipo di esercizio mentale bisogna fare per limitare il secondo?
Secondo me, lo stereotipo non è qualcosa di innato, ma lo assorbiamo con il tempo. Come dicevi, è un modo che utilizziamo per facilitare la lettura della realtà, ma è un modo che ci viene introiettato dalla pubblicità, dalla società, dalla politica, dalla narrazione che avviene al di fuori di noi. Per questo motivo, credo che si debba cambiare quella narrazione per cambiare lo stereotipo e per evitare che il nostro cervello faccia una determinata associazione mentale. Secondo me, il contrario dello stereotipo è la rappresentazione, e solo cambiando la rappresentazione si cambia lo stereotipo e, di conseguenza, il modo in cui pensiamo e associamo determinati soggetti e pregiudizi tra di loro.
Una cosa che mi ha particolarmente colpita del tuo libro è che citi soprattutto articoli accademici e giornalistici, e solo in minoranza saggi e romanzi. Secondo te c’è carenza di questo tipo di narrazioni? E perché?
Questo tipo di narrazione è aumentato soprattutto nel 2020, dopo l’uccisione di George Floyd. Ci sono stati più articoli sulla questione razziale, sia in Italia che negli Stati Uniti: negli Stati Uniti a scriverli erano giornalisti afroamericani o di minoranza etnica; in Italia invece erano i giornalisti bianchi, per cui, anche se abbiamo iniziato a coprire certe tematiche, lo abbiamo fatto sempre dal vecchio punto di vista, quello bianco. Secondo me è proprio la mancanza di rappresentazione, di inclusione, di firme di minoranza etnica nelle redazioni –- e anche nella televisione –- che ci porta ad una mancanza di bibliografia da includere nei nostri testi. Non a caso, la maggior parte degli articoli che ho citato sono inglesi o americani, e anche a livello accademico ho avvertito una forte carenza in Italia: gli stessi ricercatori italiani, quando pubblicavano, lo facevano in inglese, come se l’argomento potesse interessare solo all’estero e non in Italia.
Ci consiglieresti allora qualche titolo che trovi valido?
A metà giugno uscirà per E/O il libro di Reni Eddo Lodge, Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, che per conoscere il punto di vista britannico è un must: è scritto molto bene, è chiaro, preciso e ricco di bibliografia. Dal punto di vista americano a me è piaciuto molto So you want to talk about race di Ijeoma Oluo: è un po’ meno preciso rispetto a quello di Ranni Eddo Lodge, che ha una prospettiva accademica; Ijeoma Oluo nasce come blogger, per cui ha un tono più leggero e più leggibile che lo rende, d’altra parte, un buon primo approccio all’argomento. Tra gli italiani, è uscito da poco Corpi estranei di Oiza Queens Day Obasuyi, pubblicato da People.
Oltre a scrivere, insieme a Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso curi un podcast che si intitola Sulla Razza. Due volte al mese, per 30 minuti, traducete delle espressioni di provenienza angloamericana per metterle in comunicazione con il contesto italiano. Cosa vi ha spinto ad iniziare?
L’idea è nata lo scorso aprile, eravamo in lockdown e io stavo ancora scrivendo il libro, motivo per cui stavo ascoltando moltissimi podcast britannici (About race, con Reni Eddo Lodge) e americani (Code Switch). Mi rendevo conto che sia nello scrivere che nel parlare utilizzavo una terminologia inglese e non ero sempre sicura che questi termini fossero traducibili nel contesto italiano. Dall’altro lato stavano nascendo tantissimi podcast, ma in Italia non ce n’era uno solo che si occupasse di questioni razziali.
Mi piaceva moltissimo l’idea di mettere in relazione i termini angloamericani con il contesto italiano e provare a tradurli. Conoscevo già Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso, dato che ero stata ospite ad alcune puntate del loro podcast Sconfini e avevo già immaginato che Natasha potesse dare un apporto di tipo storico e accademico iniziale sul contesto angloamericano e che Maria potesse fornire la prospettiva di un’ascoltatrice –- essendo bianca –- e di una femminista intersezionale. Volevo che il podcast avesse una struttura fissa che presentasse una contestualizzazione storica, l’utilizzo dei termini nel contesto americano, un’eventuale applicazione nel contesto italiano, degli esempi pratici e, infine, un legame con casi specifici nel contesto italiano o una lettura di classe o femminista di queste espressioni. L’idea è nata così. La difficoltà poi è stata trovare qualcuno che lo producesse: non tutti i produttori di podcast italiani ci hanno risposto, altri hanno rifiutato; per un po’ ho pensato di rinunciare perché volevo coinvolgere il più alto numero di persone di minoranza possibile, ma volevo che fossero tutti retribuiti. Alla fine si è proposta Juventus, che ha deciso di sponsorizzare il progetto, e ora Undermedia lo sta producendo. Oltre al podcast, tra l’altro, abbiamo pensato anche una serie di contenuti extra: degli articoli su Vice, una newsletter e dei periodici approfondimenti sui social.
Tu ascolti abitualmente podcast? Ce ne consigli qualcuno?
Sì. In quest’ultimo periodo sto ascoltando A giro Pacifico, un podcast che raccoglie delle conversazioni tranquille e amichevoli che Francesco Pacifico fa con degli autori e dei personaggi del nostro tempo (tra gli altri Zerocalcare e Teresa Ciabatti). Mi piacciono molto anche i podcast di Storie Libere per il lavoro di post-produzione che c’è dietro.
Parliamo di narrativa. Qual è il tuo libro preferito?
Te ne cito due: Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez e Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar.
E l’ultimo che hai letto?
Proprietà di Lionel Shriver.
Da bambina, invece, cosa leggevi?
Quando ero ancora in Sri Lanka leggevo soprattutto miti e favole indiane o srilankesi, poi quando mi sono trasferita in Italia per un periodo non ho letto nulla perché dovevo imparare la lingua, anche se ho collezionato un sacco di libri, perché le persone intorno a me credevano che leggere fosse il modo più facile per entrare in contatto con l’italiano. Mi ricordo che il primo libro che mi è stato regalato è stato Marcovaldo di Italo Calvino: lo avevo avevo trovato difficilissimo, infatti per un po’ di anni ho odiato Calvino. Oltre a questo, leggevo narrativa italiana e inglese: ho letto Harry Potter, Bianca Pitzorno, il Battello a Vapore, Valentina, Junior Gaia. Alle medie, poi, ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura inglese dell’Ottocento, che è ancora un mio punto di riferimento.
C’è un libro che ti è mancato e che avresti voluto leggere da ragazza?
Sì, perché ho letto soprattutto letteratura europea. La letteratura indiana l’ho conosciuta da grande, tra l’altro attraverso grandi classici come Salman Rushdie e Arundhati Roy. Mi sarebbe piaciuto avere più letteratura, non soltanto quella europea, ma anche quella asiatica e africana.
Cosa fa Nadeesha quando non legge e non scrive?
Nadeesha passeggia tantissimo. Quando faccio fatica a scrivere o ho bisogno di staccare un po’ cammino: mi aiuta a riflettere, a scaricare la tensione.
Un’ultima domanda: perché e per chi scrivi?
Come un po’ tutti, scrivo prima di tutto per me stessa, in maniera quasi terapeutica. Allo stesso tempo, spero che gli altri possano riconoscersi in quello che scrivo.
a cura di Rebecca Molea