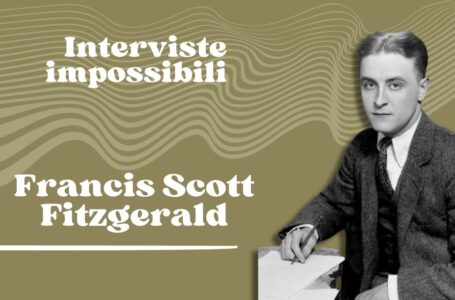Bruno Arpaia: “Noi siamo quello che di noi conservano e custodiscono gli altri”. Intervista allo scrittore tra memoria e identità

Ma tu chi sei (Guanda, 2023) è l’ultimo libro di Bruno Arpaia (1957), autore di romanzi, giornalista, consulente editoriale e tra i più autorevoli traduttori di letteratura spagnola e latino-americana. In quest’ultimo lavoro, che ridefinisce le possibilità stesse del romanzo, convergono il racconto della demenza che affligge una madre (con l’abbandono della casa di famiglia e il trasferimento in una residenza per anziani), la confessione di paure individuali e collettive e una ricognizione su quanto a oggi la scienza ha compreso riguardo la memoria e il funzionamento del cervello.
Ecco come Bruno Arpaia ha risposto alle domande di Rivista Blam!. Abbiamo parlato di mente e cervello, memoria, identità, politica e del buono che verrà.
Buona lettura!
In una pagina di Ma tu chi sei dici di non credere nella funzione terapeutica della scrittura. Se non nasce da un bisogno di tirare fuori certe cose, alleggerirsi, da dove nasce questo libro?
Nasce da una situazione personale e sociale, complessa e mai verificatasi prima. A parte la malattia di mia madre, che mette in discussione cose personali e la mia stessa identità, c’è stata la pandemia, la guerra, c’è l’avanzare dell’età che mi fa guardare all’umanità con meno speranza di quanta ne avessi prima, un po’ di disillusone politica. E questo libro non ha una funzione terapeutica o catartica, perché non è che se stai male, scrivi e stai meglio, però quanto meno ti fa conoscere. Scrivere per capire questo grumo che avevo dentro, dipanarlo. Conoscere è il primo passo per risolvere quello che è risolvibile. Poi ci sono cose che non sono assolutamente risolvibili e uno se le tiene, tipo la morte con cui continuo a fare i conti. Ci sono momenti in cui mi pare di accettarla meglio, e altri in cui proprio no.
Il titolo del libro è la domanda che la mamma anziana, affetta da Alzheimer e ormai a uno stadio avanzato della malattia, rivolge al figlio che ha iniziato a scomparire nella nebbia della dimenticanza. Ma, a lettura ultimata, l’impressione è che sia anche una domanda che il narratore pone a sé stesso. Cosa ti sei risposto?
È una domanda che ci dovremmo continuamente porre tutti quanti perché noi siamo soprattutto quello che di noi conservano e custodiscono gli altri. Quando sparisci dallo sguardo degli altri, e soprattutto da una madre, sparisci un po’ anche tu. Non c’è il punto interrogativo nel titolo del libro perché non è soltanto una domanda, ma una condizione. Invece noi ci facciamo sempre la domanda, perché queste nostre società avanzate hanno l’ossessione dell’identità che secondo me è una delle cose più pericolose al mondo. Siamo veramente ossessionati da tutti i tipi di identità possibili e immaginabili: di genere, di sesso, di classe, di razza, di etnia, nazionale, campanilistica, e inevitabilmente quest’ossessione dell’identità ci fa chiudere in una specie di corazza, distinguere noi e gli altri. Sventoliamo bandiere che sono stracci colorati, le identità sono costruzioni. Non capisco perché anche a sinistra, dove forse l’ossessione è solo un tantino più evoluta di quella della destra, siano tanto fissati, è una cosa che mi stupisce. L’ossessione identitaria non va bene, noi siamo tante cose, «siamo una sola moltitudine», come diceva Pessoa, e il bello è essere tutte queste cose, cambiare identità come si cambia d’abito. Questa sarebbe la bellezza della vita: la capacità di essere aperti agli altri e a tutti i sé possibili, e invece mi pare che andiamo nella direzione opposta.
C’è un momento del libro in cui leggi Sepúlveda a tua madre. Lei ti leggeva storie quando eri bambino?
Non tanto, perché io ho imparato a leggere da molto piccolo. Andavo in giro con mia madre che mi leggeva le insegne e da lì ho imparato. C’è un episodio interessante che dice anche molto di lei. I miei scoprirono che sapevo leggere e scrivere quando avevo quattro anni circa. A casa mia c’era una regola: quello che c’era, si doveva mangiare. Quel giorno c’era la pasta e fagioli (adesso mi piace moltissimo ma allora no) e mi rifiutai di mangiarla. Mia madre mi disse: «Finché non la mangi, non mangerai niente» e così andammo avanti fino a sera e io a un certo punto scrissi su un foglio: «Mamma e papa sono cativi». Nonostante questo – a quattro anni sapevo leggere e scrivere! – a cena dovetti mangiare la pasta e fagioli.
Il tuo libro parla di memoria, eccezionale o mancante, fallace da sempre o tradita dall’età, da una malattia. Secondo te si può comprendere senza ricordare? C’è un senso delle cose che cola dai ricordi, per addensarsi dentro di noi?
Noi vediamo più o meno quello che già conosciamo e quello che conosciamo dipende dai ricordi. Io faccio sempre l’esempio di quando sono andato al Cern con un fisico o una fisica che mi accompagnava. A 100 metri sottoterra vedevi queste macchine alte come palazzi, astronavi per me, però sapevo che il fisico o la fisica sapevano a cosa servisse ogni cavo, ogni riflettore, ogni strato del rivelatore. Vedi solo quello che sai vedere e vedi soltanto se hai memoria. In tutto ciò che oggi accade, se hai un’esperienza e ricordi accumulati, vedi cose che altrimenti non vedresti. Per questo è così importante il passato o la memoria o quello che noi ci raccontiamo della nostra vita: non tanto per ricordare il dato esatto, ma per costruire il futuro. Qualcuno ha definito il cervello «una macchina di futuro». Lo scopo del cervello non è tanto immagazzinare stupidamente ricordi ma poter prevedere il futuro. Chiunque di noi può immaginarsi da qua a tre anni in una spiaggia caraibica anche se non ci è mai stato, mettendo insieme immagini che ha visto su un giornale o su Internet, odori, ricordi, sensazioni tattili. Questa che ci sembra una cosa normale è uno dei più grandi vantaggi evolutivi di noi Sapiens. Il paradosso della memoria imperfetta è che il suo essere imperfetta la rende il vantaggio evolutivo. Altrimenti saremmo quello che dice Borges a proposito di Funes il memorioso, personaggio condannato a ricordare ogni cosa: «Sospetto che non sia capace di pensare».
Secondo te in persone come la tua mamma, quando scompare la memoria, rimane comunque la sensibilità che da quei ricordi è stata modellata?
Non te lo so dire ma credo di sì. Io so che mia madre è contenta quando mi vede, dopo di che non sa neanche chi sono. La sensibilità forse sì, ma non sa chi sono e non sa proiettarsi di lì a cinque minuti, dirti cosa faremo. È un eterno presente, una condizione secondo me terribile e che cambia da persona a persona: c’è chi ricorda il passato e non ricorda quello che è successo mezz’ora prima, mentre ad esempio mia madre non ricorda nulla, e diventa difficile interagire non avendo più un universo comune.
So che sei ateo ma ti chiedo di prestarti a un gioco. Nel buddismo si ritiene che genitori e figli si scelgano. Seguendo questa suggestione, secondo te, perché tu e tua madre potreste esservi scelti?
Ci sono tante cose di mia madre che ritrovo in me, più vai avanti e più ne scopri, mentre all’inizio pensi di essere completamente diverso. Per lo meno ai miei tempi ci si pensava in opposizione, mentre adesso vedo che non è più tanto così. Ci sono sia caratteri genetici che ambientali. Non possiamo che essere il prodotto dei nostri genitori e dell’ambiente in cui siamo cresciuti. Se la vuoi mettere così, sì, ci si sceglie, ma non lo so. Io penso che sia sano definirsi in contrapposizione, la generazione di adesso mi sembra non avere conflitto alcuno con i genitori. Credo sia giusto che all’inizio ci sia conflitto, poi maturi una sensibilità maggiore per avvertire queste sfumature caratteriali e capire che una certa parte di te ti è stata trasmessa. Un’altra parola che la sinistra ha bandito è «tradizione» e invece penso sia una parola importante se la prendi nel suo significato vero, che è appunto tradere cioè consegnare, affidare. La trasmissione può essere anche una cosa molto democratica: tu trasmetti quello che devi o vuoi trasmettere, poi la generazione successiva è libera e padrona di accettare quello che le serve e di respingere quello che non le serve. Mi sembra che anche questa semplice trasmissione di esperienza tra una generazione e l’altra a volte venga meno. Queste nuove abilità ci portano a forme di solitudine nuova. Si chiamano social ma in realtà sono prigioni individualistiche. Io poi sono un entusiasta delle nuove tecnologie ma ne vedo i rischi.
Cosa pensi della moratoria proposta da Elon Musk per fermare la ricerca di Intelligenze artificiali generative come ChatGpt? Eravamo abituati a pensare le macchine come efficienti ma prive di sfumature, adesso questo sembra venire meno. C’è un pericolo reale secondo te?
Dobbiamo definire l’intelligenza, per essere intelligenti non c’è bisogno di essere come noi. La nostra non è l’unica forma possibile di intelligenza. Io intravedo qualche pericolo nelle intelligenze artificiali anche perché ho letto libri sull’argomento e ho inteso come procedono queste ricerche. Non si pongono alcun problema su quello che chiamano «la singolarità». Noi già adesso non capiamo cosa fanno le macchine. Ad esempio, una macchina che fa deep learning, noi la avviamo ma non sappiamo che processi faccia. Come ha fatto la macchina a vincere il campione di Go? Le hanno dato le regole e lei in 24 ore ha esaminato tutto e ha fatto delle mosse che nessuno ha mai visto. È intelligente? Dal nostro punto di vista no, non sapeva neanche cosa stesse facendo, però la verità è che noi non lo sappiamo. E questo è un pericolo: ci vorrebbe una qualche forma di limite. Mentre la maggior parte dei ricercatori non si pone alcun tipo di problema. Il blocco di ChatGpt mi sembra giusto perché usa dati, e da dove li prende? Non c’è trasparenza su questo. La proposta di moratoria invece non la condivido, in sei mesi non risolvi niente. Però c’è bisogno di paletti. Se interrogati, tutti i ricercatori rispondono con le tre leggi di Asimov, ma non bastano perché la macchina può pensare di fare il bene dell’umanità distruggendo l’umanità.
Un’ultima domanda di rito: se ti chiedessi cosa ci vuole per diventare uno scrittore o una scrittrice, cosa mi risponderesti?
Ti direi di annoiarti, di leggere tanto, di cercare di avere uno sguardo sul mondo che non sia piattamente adagiato su quello che ci propongono e di buttare molto, quando cominci a scrivere quello che scrivi. Soprattutto all’inizio, devi essere molto selettivo. Se c’è qualcosa di buono, verrà.
A cura di Sara Benedetti