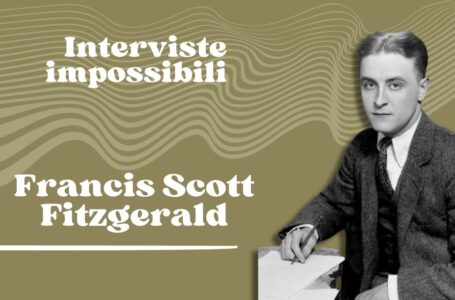Andrea Tarabbia: “Il male è una pratica sbagliata ma necessaria”. Intervista all’autore

Andrea Tarabbia, classe 1978, nel suo ultimo romanzo Il continente bianco (Bollati Boringhieri, 2022) – un’opera claustrofobica e complessa, metanarrativa, candidata al premio Strega 2023 – si muove nel disegno di personaggi e motivi tracciato da Parise nell’incompiuto L’odore del sangue per farlo suo, attualizzarlo, e continuare a ragionare su uno dei nodi tematici ricorrenti: il lato oscuro dell’essere umano. L’abbiamo intervistato per voi. Buona lettura!
Andrea Tarabbia: l’intervista
Gran parte delle tue opere si può ricollegare a un’indagine sul male. Al riguardo, cosa hai capito scrivendo?
Una cosa che ho capito è che noi siamo abituati a parlare del male in modo astratto, a pensare il bene e il male come categorie dello spirito. In realtà sia il bene che il male sono una cosa che ci è molto vicina. Il male è ciò che ci facciamo l’un l’altro, e anche il bene. È un’azione concreta. Io l’ho capito scrivendo libri, perché certi concetti filosofici o politici, che per me andavano ricondotti al concetto di male, dovevo tradurli in azioni concrete, cioè in cose che un personaggio fa, e questo mi ha fatto capire che il male è una stortura non solo del nostro animo, ma delle cose che facciamo.
Il male è una pratica sbagliata ma necessaria. In Centauri, un libro sulla violenza declinata al maschile, lo psicanalista Luigi Zoja sostiene che ciò che siamo, e anche la civiltà, è figlio di violenze, di guerre, di compromessi fatti dopo che qualcuno ha compiuto del male contro qualcun altro. Tutto il buono in cui ci riconosciamo è stato stabilito dalla violenza; magari non solo da quella, ma la violenza è stata una delle componenti fondamentali. Quindi ho pensato: se la violenza e il male hanno un ruolo primario e la letteratura è un modo per raccontare il mondo, devo andare lì. E, andando a raccontare quelle cose lì, mi sembra di aver capito questo: che il male è una pratica.
In cosa ti ha aiutato scrivere del male invece di affrontarlo con altri strumenti, ad esempio quelli forniti dalla sociologia o dalla criminologia?
A me piace, sia come lettore che come autore, guardare quelle figure, quelle persone che hanno visto il mondo da un punto di vista storto. Non è detto che io poi ci capisca qualcosa, però è un esercizio di relativismo. Significa prendere una posizione diversa rispetto al mondo e osservare il modo in cui lo vedono quelli che sono lontanissimi da me, perché so già come lo vedo io, e allora non lo ritengo interessante. Non so se è qualcosa che ho imparato, ma è qualcosa che ho voluto fare, e considero ogni mio libro una specie di tappa di un’indagine che non so se mi porterà da qualche parte. Io non ho avuto una vita interessante, non ho vissuto grandi tragedie, non sono emigrato, non ho avuto malattie. Considero la mia una vita che non offre grandi spunti per essere raccontata, tanto che il mio libro più autobiografico – Il peso del legno – è un libro nato su commissione nel quale ho capito di poter inserire alcuni elementi autobiografici; su duecento pagine, però, solo venti parlano di me. Quelle veramente interessanti sono le altre.
Leggendo la tua opera nel suo complesso, si ha l’impressione che tu sia testimone del modo in cui si incarna il male nelle varie epoche.
Non è che lo faccia in modo programmatico, del tipo «ora mi manca l’Ottocento», però sì, se guardo in retrospettiva a ciò che ho fatto, è così.
L’idea è quella di guardare fuori, nel tempo e nello spazio, tenendo fermi i narratori che mi somigliano. Una cosa che mi piace molto è fingere di essere stato testimone di fatti che in realtà non ho vissuto o, meglio, che ho vissuto indirettamente nella misura in cui li ho studiati.
La letteratura per me ha un grande valore come testimonianza – sono un lettore di biografie di sopravvissuti – ma ti permette di giocare anche con la finzione, di chiederti: se io fossi stato lì? Di essere testimone, quindi, di qualcosa che non hai vissuto e che però, per qualche motivo tuo, intimo – che a volte dichiari all’interno del libro, a volte no –, senti che ti riguarda. Questa cosa ti dà in un certo senso l’autorizzazione a scriverne, o comunque te la prendi. Ed è una cosa che ho capito negli anni. Io considero ancora adesso il mio libro migliore, quello a cui voglio più bene, Il Demone a Beslan. È un libro che mi ha creato moltissimi problemi, è il primo passo che mi ha portato a quell’elaborazione vaga di poetica che ho raccontato prima. Quando l’ho scritto ero giovane, mi chiedevo: «Ma io che diritto ho di raccontare la morte degli altri se non l’ho vissuta?». Sono riuscito a scriverlo quando mi sono detto che dovevo pensare a un modo narrativo/estetico per tradurre questa domanda e il modo è stato trovare più voci, così che non ci fosse una visione univoca. Ho cominciato quel percorso che mi ha portato a dire: «I miei personaggi sono narratori che somigliano molto a me, che partecipano poco all’azione però la determinano (per la ragione che chi osserva perturba il campo) e su questo posso costruire una poetica». Allora il gioco diventa: ok, nel Demone l’ho raccontata così, nel Giardino delle mosche l’ho raccontata affrontandola di qua, in Madrigale di là, come la racconto adesso? Il punto è che io non so quanti altri modi ci siano per raccontare qualcosa. È in questa diversità di approccio che sta la sfida.
Il tuo ultimo libro Il continente bianco prende le mosse dal romanzo L’odore del sangue di Parise. Quando è entrato nella tua vita questo romanzo?
La prima volta che l’ho letto credo fosse una decina di anni fa. Ho cominciato a leggere Parise con i Sillabari, poi le altre cose, tra cui c’era questo romanzo incompiuto non perché fosse morto l’autore, ma perché l’aveva mollato. Peraltro, Parise l’aveva scritto in una fase avanzata della vita, quando era affermato, esperto, e mi sono detto: «Se uno non riesce a finire un romanzo a quell’età, ci deve essere qualcosa sotto». E quindi l’ho letto: è un romanzo bellissimo, molto cupo, violento e amaro, di quella amarezza che provi quando sei nella fase calante della vita, preda della disillusione, perciò allora non l’ho compreso appieno. È rimasto lì, un libro bello di un autore che amo. E poi è successo che non riuscivo a scrivere Il continente bianco, progetto che avevo in mente da tempo, perché non trovavo l’ingresso in quella storia. C’è sempre un momento in cui hai un’idea per una storia, hai i personaggi, hai l’argomento, hai il paesaggio umano e non umano in cui ambientarla, però ti manca qualcosa. E c’è quasi sempre un momento in cui trovi la chiave. Per Madrigale senza suono è stato quando ho capito che ci sarebbero state le chiose di Stravinskij. Io avevo già tutta la storia, stavo iniziando a scriverla, però sentivo che mancava qualcosa. Mi sono detto: «Questa non può essere solo la storia di Gesualdo, anche perché altri l’hanno già raccontata, però se è la storia di Gesualdo commentata e contraddetta da Stravinskij, scritta nel momento in cui decide di comporre un’opera su Gesualdo, allora ha più senso». Ecco, il momento in cui succede questa cosa per Il continente bianco arriva quando, durante il lockdown, rileggo L’odore del sangue e mi dico: «Lo uso come se fosse un documento storico, facilitato dal fatto che Parise non l’ha finito; ha lasciato degli spiragli aperti, ho degli spazi per intervenire». Poi c’è la fase in cui ti domandi: «Ma è una cazzata?». Allora chiedi a poche persone fidate e ti dicono che no, non è una cazzata. Poi lo sai anche da te che l’idea è buona, ma ti serve un incoraggiamento per partire.
In L’odore del sangue, in effetti, c’è un personaggio che si presta molto al lavoro che tu fai su Marcello Croce.
Esatto. Dal romanzo di Parise sai che ha venticinque anni, non ha una professione, ha mollato il teatro, ha mollato la palestra, è dentro Ordine nuovo. Non ha grande caratterizzazione se non questa appartenenza e il fatto che è violento con le donne. Costringe Silvia a un’escalation di pratiche sessuali fino alla prostituzione; lui però è sempre al di là della parete. Io mi sono detto: «Vado di là io oppure lo porto qua, vediamo cosa succede». In realtà si rivela una cosa anche molto divertente perché c’è uno scheletro fornito da Parise (il crescendo drammatico del rapporto tra il ragazzo e Silvia) e però anche un sacco di buchi, di ingressi dai quali puoi entrare e giocare con i personaggi, plasmarli, perché a questo punto tu vedi tutto dalla prospettiva di Marcello, prospettiva che nel romanzo di Parise non c’era. La Silvia di Parise è una Silvia vista dal marito. La Silvia del mio romanzo è una Silvia vista dal narratore, ma anche attraverso il filtro degli occhi di Marcello. Quindi è la stessa persona ma, vista da uno sguardo diverso, sembra avere una personalità diversa.
Tu trasporti la storia ai giorni nostri. Volevo chiederti a questo proposito: il titolo L’odore del sangue sembra richiamare una forte sensorialità, mentre Il continente bianco rimanda quasi a una privazione di colori. In questo passaggio da una maggiore sensorialità a una minore c’è anche la volontà di cogliere una trasformazione storica dell’Italia avvenuta dai tempi in cui scriveva Parise a oggi?
È una domanda a cui è difficile rispondere innanzitutto perché io non ho vissuto gli anni Settanta, li conosco per averli studiati. Parise ha scritto un libro in cui la componente carnale, sessuale e sensuale è dominante. Nel momento in cui vuoi fare una sovrascrittura, se usi lo stesso grado di carnalità e sensualità, perdi, perché ti stai mettendo proprio sullo stesso piano della fonte. Allora mi sono detto: «Questa componente c’è anche nel mio romanzo, ma la devo virare. Ci deve essere più teoria, anche un certo distacco». Io volevo che Marcello fosse più freddo, e che fosse rovente il mondo che gli sta intorno, però lui doveva rappresentare un esercizio fisico freddo e raziocinante della violenza nella misura in cui c’è una componente anche sociologica nella concezione del romanzo. Quello che trovo davvero problematico riguardo alla crescita dei movimenti di estrema destra dentro il Parlamento e fuori è l’accettazione da parte della società civile. Tolleriamo cose che negli anni Settanta o Ottanta o Novanta erano ritenute inaccettabili nel linguaggio, nel comportamento, nella postura del corpo di certi leader politici più o meno ufficiali, per contestare le quali si scendeva in piazza. Oggi la mia sensazione è che tutti siamo diventati più freddi, meno sensibili nei confronti di una serie di comportamenti che sono anticostituzionali. Allora mi sono detto: il mio gruppuscolo di fasci deve esercitare questa cosa, mettere in scena fin dal nome una certa forma di asetticità. Poi, in realtà, il nome fa più riferimento al white power, l’idea per cui l’Europa deve essere un continente bianco fatto da bianchi. E c’è anche una serie di riferimenti letterari: tutto il discorso sulla bianchezza che fa Melville che la lega ai fantasmi, ai sudari; qualcosa di impassibile, di impalpabile e freddo.
Nel romanzo ci sono dei correlativi oggettivi che rimangono impressi: il video con i topi, la statua della Madonna sul cui mantello sembra colare sangue, il tatuaggio della ragazza ma anche la strana scultura che ha lo psicanalista… che funzione hanno?
In quasi tutti i momenti in cui il narratore è davanti a un bivio, a una scelta di qualche tipo, compare uno di questi correlativi oggettivi che servono a lui come approdo, ma servono anche al lettore e a me. La presenza degli animali è una costante dei miei libri, mentre sono del tutto assenti nella mia vita. Nel mio materiale preparatorio c’è sempre una pagina di appunti in cui scelgo l’animale guida del romanzo perché è un modo per raccontare cose banali in modo non banale. Per raccontare sentimenti che, così come sono, si esaurirebbero in una frasetta, e che invece il comportamento animale, che puoi allargare a un personaggio, ti permette di dire in modo interessante. Questo stesso discorso vale per tutti i correlativi oggettivi.
Perché hai sentito l’esigenza di rivolgerti ogni tanto ai lettori? Perché, come i correlativi oggettivi per il narratore, siano un approdo, un appiglio per te scrittore?
In realtà io volevo fare un libro degli anni Settanta a livello di stile, di struttura, di linguaggio. E facevo riferimento ad alcuni autori che amo, ad esempio Guido Piovene, in cui a volte c’è questo elemento. E poi perché ciò si ricollega al discorso di rinnovare una forma, trovando sempre nuove visuali, di cui parlavo prima. Nei miei libri precedenti non c’era mai stato un riferimento esplicito ai lettori, quindi volevo farlo. Il continente è un libro dove la parte metaromanzesca è forte, non solo perché c’è la riscrittura di un romanzo, ma anche perché dentro ci sono citazioni più o meno esplicite e poi c’è una parte in cui il narratore riflette su cosa voglia dire scrivere, sul rapporto tra autore e personaggio. Era giusto che qualcuno ricordasse ogni tanto a chi legge che siamo dentro un libro. Visto che costruisco un gioco di libri che raccontano di libri, io ogni tanto dico al lettore: «Ricordatelo».
Il personaggio del narratore si chiama come te e Parise non nascose che nel suo romanzo c’era molto di sé stesso. È stata una scelta che ti è venuta naturale?
Fino a un certo punto. All’inizio non era così. Nel primo capitolo, che ho riscritto tante volte perché lì riposava il nucleo di tutto, c’è la scena in cui il narratore è nel salotto con Silvia, le ha firmato la copia e insieme aspettano che torni il dottore, e quando arriva mi è venuto naturale scrivere: «Oh Tarabbia, eccola qui», e mi sono sorpreso, mi sono fermato. Ci ho pensato, l’ho messo, l’ho tolto, alla fine l’ho tenuto perché mi sono detto: «Questo libro non posso raccontarlo come Filippo perché Filippo l’ha già raccontato ed è Parise (che poi è il motivo per cui non l’ha finito, perché era come mettersi in piazza); non lo posso far raccontare da Silvia perché Silvia non frequenta gli ambienti di estrema destra, non lo posso far raccontare da Marcello perché Marcello non va dallo psicologo». A tutti mancava un pezzo. «Chi è che lo può raccontare? Un paziente che vede tutto, conosce tutto, racconta la storia di tutti ed è il narratore. Io». Implicitamente, presuntuosamente, se tu fai un libro così, chiami un confronto con l’autore da cui parti e l’autore da cui parto ha messo nell’Io narrante sé stesso. E a questo punto, ho dato al narratore il mio nome ma non ci ho messo me stesso.
Sei in concorso per il premio Strega, hai vinto il Campiello nel 2019, sei un docente di narrazione. Qual è l’ingrediente che suggeriresti a un apprendista scrittore o scrittrice?
Leggere tanto e scrivere pochissimo. Scrivere quello che siamo sicuri ci rappresenti davvero e per capire questa cosa, secondo me, per ogni libro che si scrive bisogna leggere duecento autori. Devi trovare quelli e quelle che ti somigliano e nel cui modo di fare ti riconosci, perché dentro quello che loro hanno scritto c’è probabilmente quello che potresti scrivere tu. È una cosa difficilissima che prevede che tu legga cento libri e in novantotto non trovi nulla. Magari ti piacciono ma non c’è quella cosa. Ma poi arrivano quei due e lì inizia tutto.
A cura di Sara Benedetti
Foto di apertura di Yuma Martellanz