V13 di Emmanuel Carrère: cronaca del maxiprocesso durato 9 mesi per gli attentati terroristici di Parigi del 2015
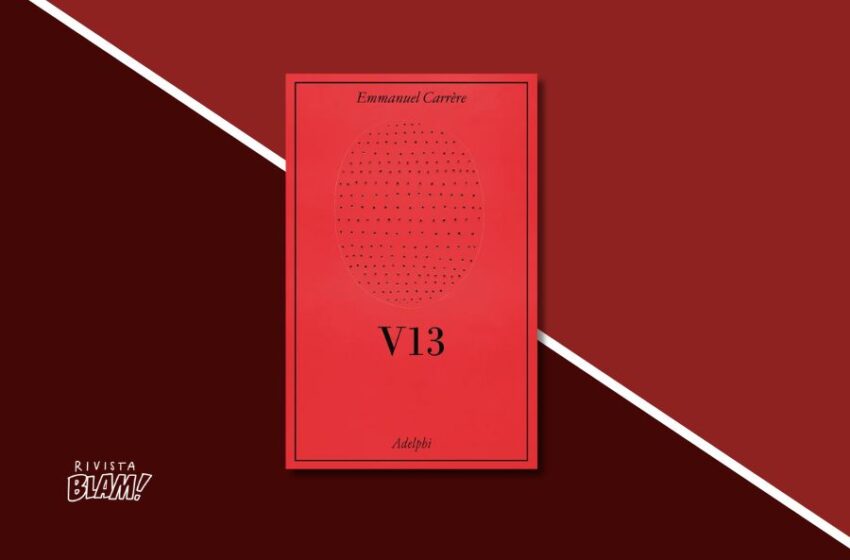
V13 di Emmanuel Carrère (Adelphi, 2023) è, come recita il sottotitolo, una «cronaca giudiziaria». Carrère, reduce dall’uscita di Yoga (uscito in Italia nel 2021 per Adelphi), nell’autunno 2020 scrive un breve messaggio a Jérôme Garcin, responsabile delle pagine culturali dell’«Observateur» per proporsi come inviato: «Ci conosciamo, lei conosce il tipo di cose in cui mi trovo a mio agio: niente opinioni ma lavoro sul campo». Così Carrère entra in un reparto di psichiatria infantile e scrive Les enfants de la Pitié che esce sul giornale nel gennaio 2021 e racconta di una gioventù derubata della bellezza dell’età e fuori equilibrio. A questo breve reportage letterario – è pur sempre Carrère che scrive – segue la controproposta del giornale: seguire il maxiprocesso per gli attentati terroristici del 13 novembre 2015, quel venerdì in cui Parigi ha avuto paura. Carrère accetta e siederà per nove mesi, l’intera durata del processo, sulle scomode panche di un’aula di tribunale appositamente costruita. L’uomo che uscirà da quel tribunale non è lo stesso che ci è entrato. Ha, forse, più domande nella testa e ha anche versato lacrime, lui che, a suo dire, non lo fa mai.
V13 di Emmanuel Carrère: la trama del libro
Per maneggiare il materiale di un processo durato nove mesi, per non esserne sopraffatto, Carrère dà al volume in cui sono raccolti i suoi resoconti settimanali usciti sull’«Observateur» una struttura riconoscibile, disegnata sui protagonisti del processo: prima parte le vittime, seconda parte gli imputati, terza parte la corte.
Prima di iniziare il viaggio nello strazio, nell’assenza, nelle ragioni e nei torti, Carrère ci dà le coordinate: è l’8 settembre 2022, siamo a Île de la Cité. Nessuna delle sale del palazzo è abbastanza grande, quindi è stata costruita nell’atrio dell’edificio una scatola di tamburato bianco, senza finestre, lunga 45 m e larga 15 m, che contiene fino a 600 persone. I controlli per poter accedere all’aula sono talmente accurati da far rinunciare alla tentazione di uscire per poi rientrare. I giornalisti che seguiranno il processo, come Carrère, trascorreranno sostanzialmente nove mesi lì dentro, uscendo solo quando è già buio per andare a dormire e ritrovarsi sempre lì, il giorno seguente.
Il presidente della corte è Jean-Louis Périès, magistrato prossimo alla pensione, figlio di magistrato, uomo solido e di grande esperienza.
Dei venti imputati del processo, quattordici sono presenti e undici di questi si trovano all’interno di un box di vetro verso il quale i sopravvissuti e i parenti delle vittime non sempre riescono a rivolgere lo sguardo. Chi riesce a farlo, chi riesce a guardare, all’interno del box vede i principali imputati: Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Mohamed Bakkali, Adel Haddadi e Muhammad Usman.
Durante il processo vengono ascoltate circa 1800 vittime (superstiti o parenti delle vittime) dei tre attentati avvenuti il 13 novembre: al Bataclan durante un concerto degli Eagles of Death; fuori dallo Stade de France, dove si giocava l’amichevole Francia-Germania, e nei dehors di due locali, Le Carillon e Le Petit Cambodge.
Périès chiede, per abbreviare i tempi, di «evitare le ripetizioni», ma è una gaffe che si poteva evitare: «[…] non ci sono e non ci possono essere ripetizioni, perché quegli stessi momenti ciascuno li ha vissuti con la sua storia, con le sue conseguenze, con i suoi morti, e li racconta adesso con le sue parole. Non sono fatti che si elencano e si esauriscono».
Il processo si conclude il 7 luglio del 2022 con la lettura della sentenza a opera del presidente della Corte e con il racconto di questo giorno si conclude anche la cronaca giudiziaria di Carrère: «Ce ne accorgiamo stasera, tutti, anche quelli che come me erano soltanto degli osservatori: questo è stato il nostro processo, e ora è finito».
«Amore per l’uomo più difficile da amare»
Il secondo giorno del processo si alza uno degli imputati e, quando il microfono viene attivato, chiede se sarà data la parola anche a quelli che vengono bombardati in Iraq e Siria. Il presidente di Corte risponde che se ne parlerà a tempo debito. Il processo è appena iniziato e già una questione enorme è stata scomodata. Dal 2014 una coalizione internazionale di cui faceva parte la Francia ha sganciato su Iraq e Siria bombe che hanno causato centinaia di vittime perché «i bombardamenti chirurgici sono un mito». Eccola, la questione. La matrice del terrorismo jihadista potrebbe risiedere nella politica coloniale e di aggressione che l’Occidente (e la Francia, da protagonista tra gli Stati europei) conduce da tempo in Africa e Medio Oriente?
È una domanda che fa il paio con un’altra, scomoda anche lei, che circola non in quest’aula ma ovunque e che si chiede se la disinvoltura con cui l’Europa è andata a saccheggiare le risorse di un altro continente possa essere identificata come causa dell’emergenza dei migranti nel Mediterraneo. In un caso e nell’altro ciò che auspica l’Europa bianca ricca e cattolica o protestante è che restino a casa loro, ciò che si nega è che ogni causa comporta un effetto, non solo in fisica ma anche in politica internazionale. L’altra questione difficile – e stavolta sono i resoconti delle vittime che la portano a galla – è perché a pagare debbano essere degli innocenti.
I racconti delle vittime sono quelli più scomodi e dolorosi, quelli che occupano moltissimo tempo del processo, quelli a cui Carrère dedica pagine e pagine, ritagliando per noi dalla folla di 1800 alcuni ritratti che non dimenticheremo: c’è chi afferma che da quel giorno non sogna più. «I sogni hanno disertato le mie notti», c’è Nadia che il 13 novembre ha perso sua figlia e che ancora non riesce a capire: «Pensare che quelli che l’hanno uccisa avevano la sua età. L’età di tutti loro tra i venticinque e i trent’anni. Che sono stati accompagnati a scuola, tenendoli per mano, come lei accompagnava Lamia tenendola per mano. Erano dei bambini che venivano tenuti per mano».
C’è Georges, anche lui ha perso sua figlia, Lola. «Georges dice che non si lotta contro la barbarie con la barbarie e che ciò che giustifica un simile processo è lo scrupoloso rispetto della norma giuridica». È tra i sostenitori della cosiddetta «giustizia riparativa» e ha scritto un libro a quattro mani con Azdyne Amimour, padre di uno degli assassini di sua figlia. Il libro si intitola Il nous reste les mots (Ci rimangono le parole).
«Georges Salines è un uomo assolutamente civile, cui mi piacerebbe somigliare se mi capitasse una disgrazia simile. Eppure, quell’arcaico furore che dobbiamo imparare a superare, prima di superarlo dobbiamo riconoscere che esiste – perché esiste per forza, altrimenti non saremmo umani». Eccolo, allora il punto centrale e dolente: noi che «ci somigliamo, ci capiamo, ci riconosciamo» e «loro che non ci somigliano, non conosciamo, non capiamo» forse non siamo così dissimili.
Daisaku Ikeda, leader religioso buddista, scrive nella proposta di pace del 2019 inviata all’Onu: «Se vogliamo veramente porre fine all’era degli armamenti nucleari, dobbiamo lottare contro il vero nemico, che non sono le armi atomiche di per sé, né gli Stati che le possiedono, bensì il modo di pensare che ne permette l’esistenza: la prontezza ad annientare gli altri quando vengono percepiti come minaccia o impedimento alla realizzazione dei propri scopi». E la reale portata di questa affermazione che va oltre e prima del nucleare, è difficile da cogliere, è scomoda perché ci ricorda che, parlando di disarmo, non si può prescindere dal «disarmo interiore». E perché vale in entrambi i sensi: vale per loro che non conosciamo e inneggiano alla nostra morte, la morte degli infedeli, e vale per noi che vorremmo ridurre il diverso all’uguale oppure toglierlo dall’equazione del nostro presente.
Sempre Georges, al termine della sua deposizione, cita Jankélévitch: «L’amore per il malvagio non è amore per la sua malvagità; sarebbe una perversione diabolica. È soltanto amore per l’uomo stesso, per l’uomo più difficile da amare». Queste parole ricordano la risposta di Cremete a Menedemo nell’opera di Terenzio, Il punitore di sé stesso: «Homo sum, humani nihil a me alienum puto». Sono un uomo, e non c’è niente di umano che mi sia estraneo.
La scrittura di Emmanuel Carrère in V13
Carrère, tra i più importanti esponenti del genere letterario definito «autofiction», è narratore esperto, abituato a portarci a spasso nel mondo, a conoscere luoghi o personaggi da noi distanti, mentre eventi della sua vita fanno da contrappunto a una narrazione che potrebbe diventare troppo «esotica» per essere seguita fino in fondo. Al timone, in questo traghettarci tra mondi diversi, Carrère sembra essere al suo posto. È nato per fare questo. È dotato di un’intelligenza brillante che sa notare le minuzie e porsi le domande giuste. È un grande affabulatore, sa aprire digressioni dentro digressioni, incantando chi legge, senza perdere mai la direzione, lui. Ha una scrittura ricercata e accessibile al tempo stesso. La cura della sintassi, la perfezione con cui conia le frasi, non le si nota di primo acchito perché l’effetto più evidente è la scorrevolezza con la quale le pagine scivolano sotto gli occhi e l’eco che registrano nell’impatto con la vita di chi legge. Il pensiero è scritto così bene che arriva liscio, come una palla da bowling su una pista oliata per mandare all’aria le convinzioni a cui ci radicavamo. È un sovvertitore di finti equilibri Carrère, un vero intellettuale, un cesellatore di dubbi, qualcuno di cui si sente il bisogno.
A cura di Sara Benedetti











