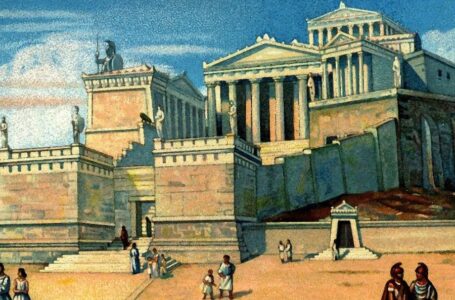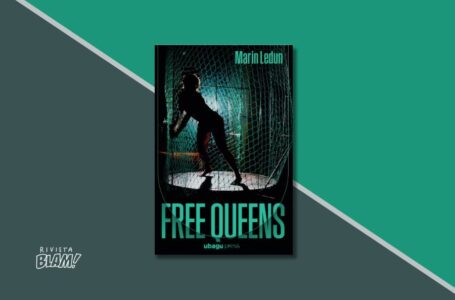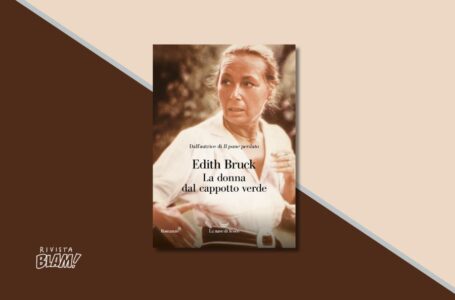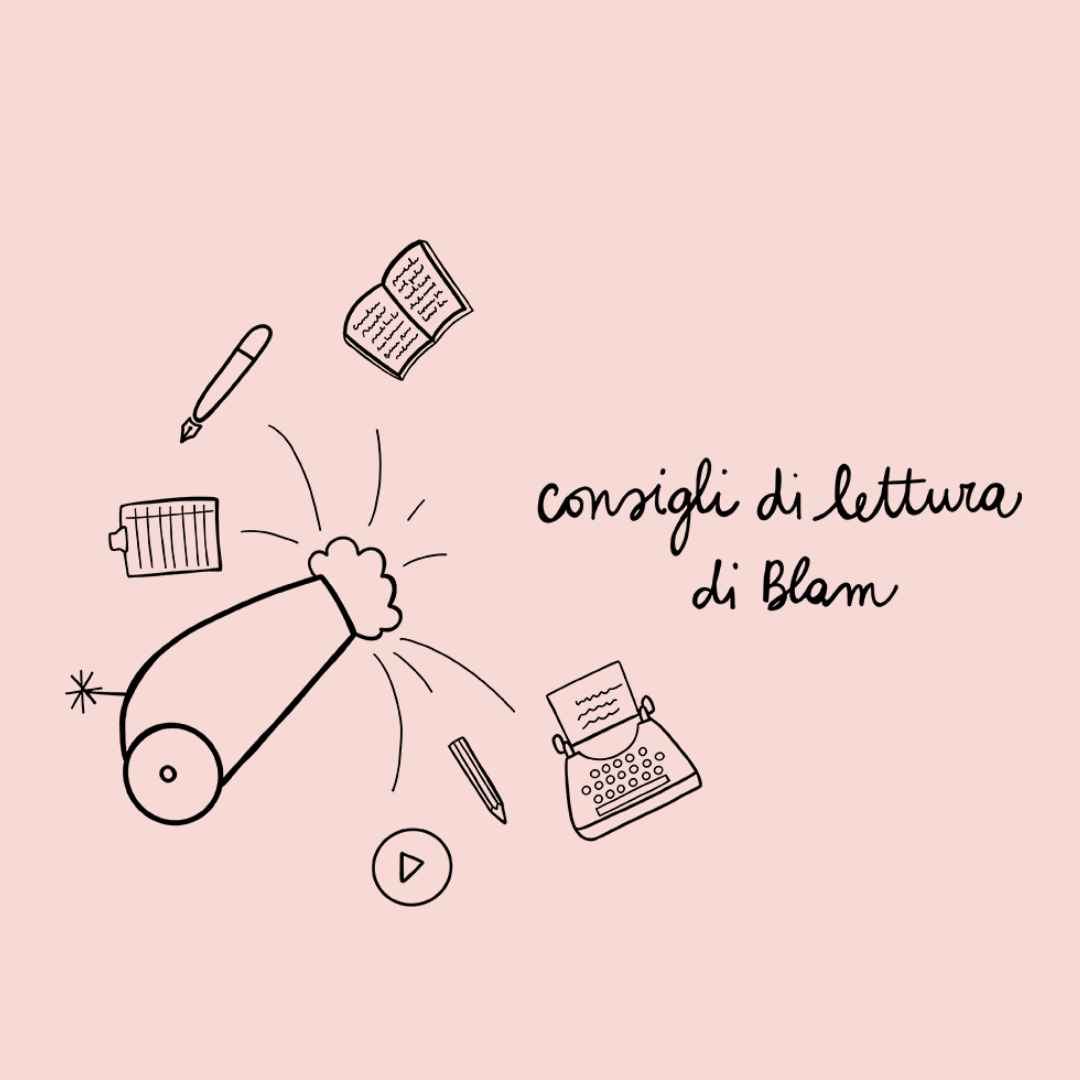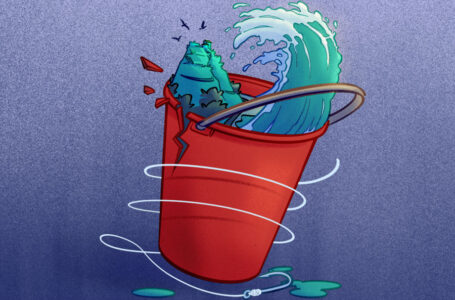“Carissimo Billy”, il diario dell’amicizia fra la traduttrice segreta di Vittorini e uno sciupone della vita

Grazie a 8tto Edizioni, arriva a noi Carissimo Billy, dear Lucky, il poetico carteggio che Lucia Rodocanachi e Guglielmo Bianchi intrattennero per dieci anni. Sullo sfondo di un’Italia alle prese col periodo fascista prima e con il secondo conflitto mondiale poi, queste lettere raccontano non solo gli aspetti intimi dei due artisti, ma anche tutti i fermenti culturali di quell’epoca. A curare la raccolta è stata Benedetta Vassallo.
Carissimo Billy, dear Lucky di Lucia Rodocanachi e Guglielmo Bianchi: di cosa parla il libro
Carissimo Billy, dear Lucky (8tto Edizioni, 2024) è il carteggio a due voci fra due interessantissime figure del Novecento italiano, Lucia Rodocanachi e Guglielmo Bianchi, intellettuali e artisti di spicco del panorama culturale del secolo scorso. I due, dal 1937 al 1947, intrattengono una fitta corrispondenza epistolare, che svela il loro rapporto di intima amicizia e profonda affinità. Questo libro raccoglie infatti, sotto la cura di Benedetta Vassallo, 34 lettere selezionate che i due amici si sono scambiati nell’arco di questi dieci anni e che rappresentano in modo significativo una testimonianza esclusiva della parabola personale e artistica di entrambi in un’epoca cruciale per il nostro Paese e per l’Europa intera.
Il fermento culturale e gli amici degli anni Trenta
Sono gli anni Trenta. Lucia, nata a Trieste e di origini ebree, si forma a Genova e studia all’Accademia linguistica di Belle arti. Nel 1930 sposa il pittore Paolo Rodocanachi, soprannominato Cian, e che la introduce anche nella sua cerchia di amici pittori, intellettuali e artisti. Insieme a lui si trasferisce nella cosiddetta «casetta rosa» ad Arenzano, sulla riviera ligure, che diventa rifugio e crocevia di una comunità cenacolo: «Gli amici degli anni Trenta». Fra gli illustri frequentatori, appartenenti all’intellighenzia culturale del tempo, vi sono: i poeti Angelo Barile, Camillo Sbarbaro, Adriano Grande, Oscar e Fausto Saccarotti, il pittore Emanuele Rambaldi, e ovviamente Guglielmo Bianchi. Quest’ultimo, artista eclettico, poeta, viaggiatore, sceneggiatore e mecenate, trascorre la sua rocambolesca vita tra Lavagna Genova e Parigi, per poi fuggire in Sud America, a Buenos Aires, dal fratello Alberto. Autore di due raccolte di poesie – Sciamiti e Sestante –, e di una di prosa, Eleganze, diventa anche finanziatore della rivista di poesia «Circoli», fondata a Genova nel 1931, dedita a dare impulso e spazio, attraverso la traduzione, alla letteratura d’oltremanica e d’oltreoceano.
Affinità elettive
Lucia e Guglielmo consolidano la loro amicizia sul terreno dell’arte e della letteratura, un mondo in cui si riconoscono e trovano un senso di appartenenza condiviso.
Lucia è per Guglielmo la sua «dinamo» e musa ispiratrice. Per lei, invece, Guglielmo è come l’«ostrica allo scoglio», per la sua sfuggevolezza e capacità di scomparire, alle volte, senza lasciare traccia. Le loro lettere, infatti, sono un appiglio importante a cui i due si aggrappano in particolare nei mesi di incolmabile distanza. Ci sono perciò passaggi in cui Lucia rimprovera spesso gli esili volontari dell’amico, le sue assenze prolungate e lunghi silenzi.
«Mio caro scrivi e scrivi presto e scrivi spesso. Aspetto le tue lettere come si aspetta il superfluo, cioè la vera cosa necessaria per gli esseri irrazionali come me. Disprezzami ma ricordami e scrivimi».
Eppure le sue continue invocazioni suscitano spesso da parte dell’amico risposte brusche, sarcastiche e alle volte arroganti, accompagnate al contempo dalla paura di essere, un giorno, tagliato fuori dall’universo degli affetti amicali e familiari. Guglielmo, infatti, perennemente inquieto e insoddisfatto, appare diviso tra il desiderio di libertà e solitudine, tra la voglia di scomparire nell’oblio e il bisogno di sopravvivere nella memoria degli amici. Da una parte si ribella ai continui moniti di Lucia, dall’altra chiede spesso notizie sue e degli amici che hanno in comune, e ricorda con nostalgia i loro incontri e il paesaggio ligure, sua terra d’origine, che diventa durante il periodo all’estero un piccolo «campo trincerato nel ricordo».
La «negritudine» e il contributo segreto delle donne nella cultura del Novecento
Non avendo scritto nessun’altra opera in senso letterario, queste lettere (come anche quelle scambiate con Sbarbaro, Montale e molte altre amiche scrittrici) rappresentano per Lucia, come ha sottolineato Benedetta Vassallo, la sua opera assoluta, il suo «romanzo non scritto». E consegnano a noi lettori e lettrici momenti di altissima espressione poetica ed emotiva. Con l’identificazione nel personaggio evangelico di Marta, patrona delle domestiche, Lucia si sente intrappolata entro un contesto ripetitivo e privo di stimoli, in netto contrasto con le sue reali aspirazioni e vocazioni letterarie. La mancanza di impegni quotidiani, di contatti sociali e la solitudine, dovuta anche ai frequenti viaggi del marito, rivelano un sentimento di irrequietezza, senso di abbandono e timore di scomparire anche lei senza lasciare traccia, «come un oggetto di poco uso della cui scomparsa ci si accorge a volte dopo mesi o dopo anni. […] Quello della mia inesistenza è l’idea fissa, mi sento obliterata, cancellata, una larva che continua per abitudine certe azioni materiali o a credere di compierle meglio».
È in questa cornice di immobilità e austera vita provinciale che Lucia dedica una buona parte del suo tempo all’attività di traduzione, che definirà nelle lettere négresse inconnue, ovvero «negritudine»: per il suo lavoro di sconosciuta suggeritrice e consulente delle traduzioni, che svolgeva per e su richiesta di amici, come lo scrittore siciliano Elio Vittorini. Un caso che, a posteriori, mette in luce il contributo silenzioso e ancillare anche di tante altre figure femminili che hanno preso parte alla mediazione editoriale e culturale del tempo, ma che sono tuttavia rimaste all’ombra di traduttori affermati e riconosciuti. Lucia veniva infatti periodicamente interpellata oltre che da Vittorini, anche da Montale, Gadda e Sbarbaro, sulla possibilità di fornire capitoli o interi lavori di traduzione di scrittori inglesi e americani e di consigliare letture per nuove pubblicazioni, senza mai però rendere nota la propria collaborazione.
Voci nel conflitto: lettere di guerra e speranza
Un altro aspetto che emerge da questo epistolario è inevitabilmente anche la cornice bellica di quegli anni. L’inizio del secondo conflitto mondiale segnerà le vite di Guglielmo e Lucia, e sarà un freno alla loro corrispondenza per le rispettive vicissitudini personali. Lucia viene infatti deportata e incarcerata a Genova e, una volta uscita di prigione, nel 1944, è costretta a rifugiarsi con il marito in Valle Cantarena, insieme a tanti altri sfollati.
Bianchi invece attenderà la fine della guerra, per tornare nel 1947 a Lavagna, in Liguria, dove morirà nel 1966. Fino a quel momento, come riporta nelle sue lettere, rimane imprigionato metaforicamente in un presente di cui si ritiene ormai solo un inutile spettatore e al quale non riesce più a partecipare. I toni con il quale scrive sono affranti e ormai del tutto rassegnati. Degli ultimi anni di corrispondenza, a giungere sino a noi sono soprattutto e proprio le sue lettere, che Lucia aveva continuato regolarmente a conservare nella speranza di rivederlo e riabbracciarlo presto.
A cura di Clara Frasca