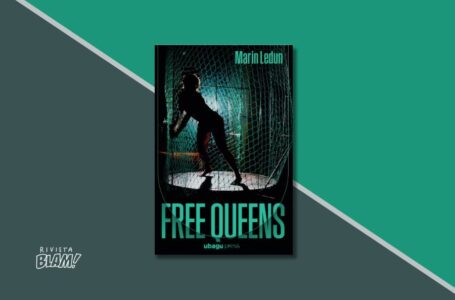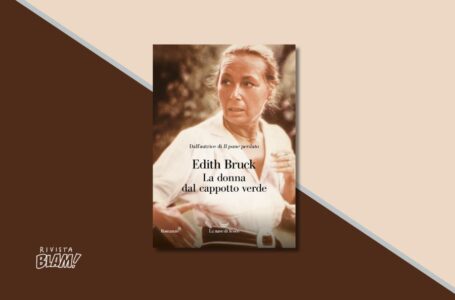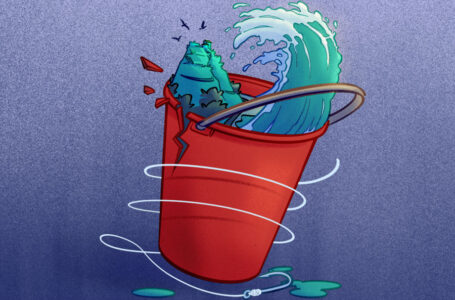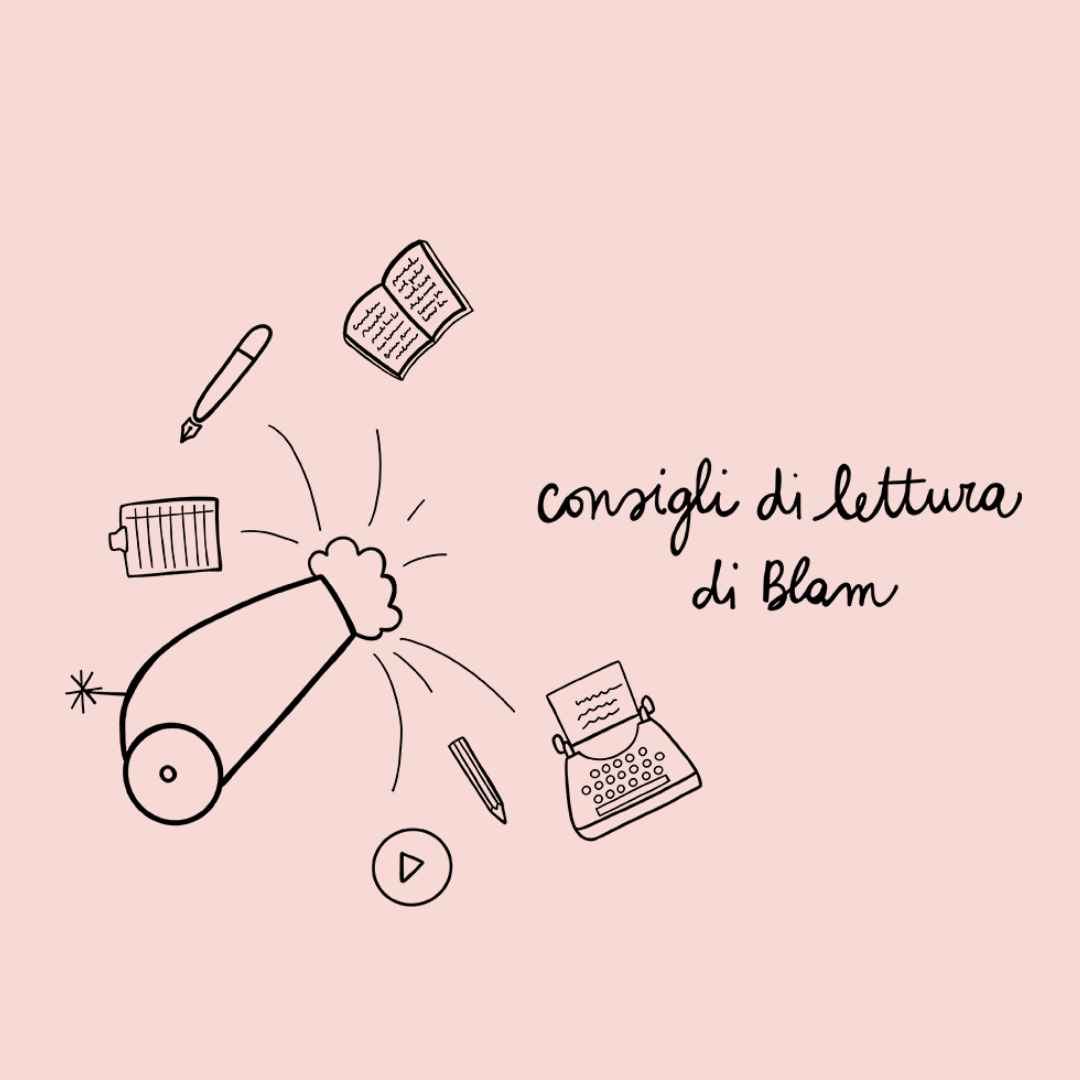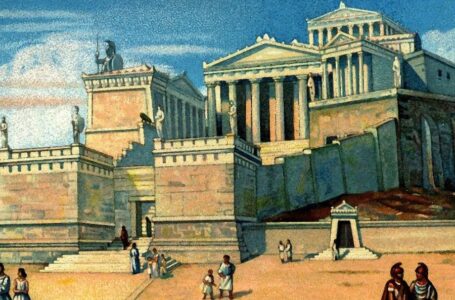La letteratura greca non è solo quella classica: gli autori moderni greci e i libri da leggere
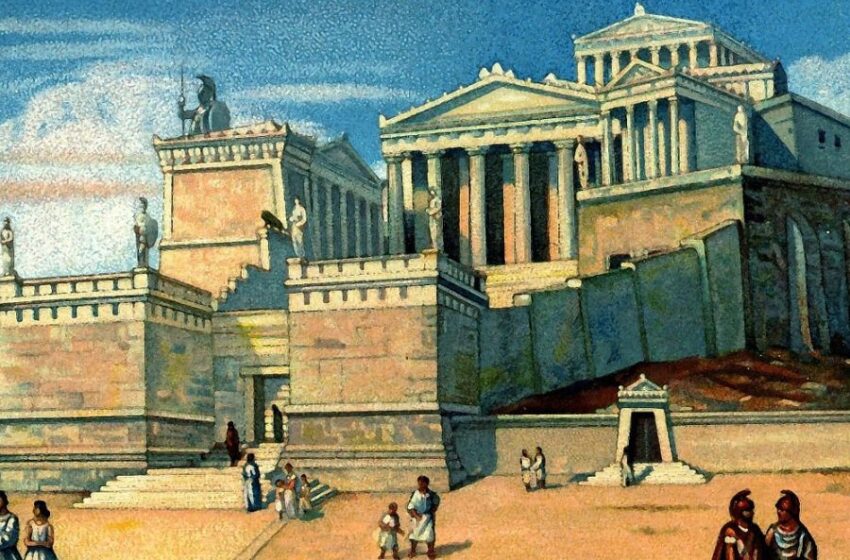
Si parla poco della cultura greca moderna, e ancora meno del suo panorama letterario e editoriale. È più facile, infatti, che si conoscano le grandi figure della Grecia antica, come Omero, Aristotele e Platone, piuttosto che scrittori più recenti e vicini a noi, come Alexandros Papadiamantis o Nikos Kazantzakis. Tuttavia, considerare la letteratura greca esclusivamente sulla base dei testi classici, e ignorare le evoluzioni più moderne, sarebbe una visione troppo riduttiva, che ci priva di uno sguardo sulle inclinazioni letterarie e le istanze odierne. In Grecia continuano ancora oggi a esserci autrici e autori di grande valore letterario, capaci di conservare da una parte un legame con le proprie radici storiche, e dall’altra di rinnovarsi continuamente facendo sentire la propria presenza nella scena letteraria mondiale.
I temi ricorrenti della letteratura greca contemporanea
A partire dai primi anni del Novecento, eventi dolorosi come lo scambio di popolazioni del 1922, la dittatura dei colonnelli negli anni Settanta o la crisi economica iniziata nel 2008, sono stati momenti significativi nella Storia più recente della Grecia e che inevitabilmente hanno trovato spazio anche nella letteratura greca contemporanea. A essere raccontati sono il senso di repressione e malessere sociale, la disillusione e la ricerca di un riscatto collettivo. Troviamo opere che narrano l’amore per la propria terra, l’identità nazionale, il «modo di vivere greco», le tradizioni popolari. Ma c’è anche una profonda introspezione psicologica, il senso di smarrimento, la paura del presente e il dramma esistenziale.
Autrici e autori greci tra modernità e tradizione
Sul finire dell’Ottocento, la letteratura greca contemporanea si sviluppa in un contesto nuovo, segnato dalla fine dell’occupazione ottomana, l’emergere della modernità, le guerre balcaniche, i due conflitti mondiali, le difficoltà politiche ed economiche. Nonostante il passato classico rimanga una fonte di ispirazione costante, le autrici e gli autori contemporanei si confrontano con le sfide di una società in rapido cambiamento. Voci come Stratis Doukas, Stratis Myrivilis e Ilias Venezis, pur con stili e approcci differenti, raccontano scenari di guerra, violenza e morte, vissuti in prima persona. Myrivilis ci offre nel romanzo La vita nella tomba (Asterios, 2016) una testimonianza straziante della propria esperienza vissuta durante le guerre balcaniche. Venezis, con Il numero 31328 (Edizioni Settecolori, 2022), ci conduce nella drammatica tragedia dell’Asia Minore del 1922, che i greci chiamano la «catastrofe microasiatica»: una cronaca corale che racconta l’esodo forzato di greci e turchi dalle proprie terre d’origine. Nella prima metà del Novecento si sono affermate anche altre figure straordinarie, come il poeta alessandrino Konstantinos Kavafis, il drammaturgo Angelos Sikelianos e il romanziere cretese Nikos Kazantzakis. Quest’ultimo ha raggiunto la fama mondiale grazie al celebre romanzo Zorba il greco (Crocetti, 2021), adattato per il cinema nel 1964 dal regista Michael Cacoyannis. Altri suoi capolavori che meritano di essere menzionati sono: Cristo di nuovo in croce (Mondadori, 1955), L’ultima tentazione (Crocetti, 2021) e Odissea (Crocetti, 2023), opera monumentale che costituisce una sorta di ideale prosecuzione del capolavoro omerico.
Odysseas Elytis e Ghiannis Ritsos riprendono invece la tradizione lirica e tragica del repertorio classico, mescolando mito e storia con la realtà contemporanea. Elytis, vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 1979, reinterpreta la tradizione greca in chiave moderna, affrontando il tema dell’assenza, dell’ora e della poesia pura; l’attivista di sinistra Ritsos intona invece elogi alla fratellanza proletaria e ricorda la sofferenza del popolo greco durante la dittatura militare (1967-1974), con riferimenti alla memoria storica e al trauma collettivo. Anche la poesia surrealista di Andreas Embirikos segna un passo decisivo verso la modernità, esplorando la dimensione astratta e psicologica della condizione umana. È considerato il primo poeta surrealista greco, e la sua raccolta Amur Amur (1966) è il manifesto di questa nuova corrente da lui qui inaugurata. Il dramma individuale ed esistenziale è invece un concetto espresso con profonda intensità dal poeta «errante» Ghiorgos Seferis, premio Nobel per la Letteratura nel 1963, il quale esplora nelle sue liriche il senso di solitudine, la sofferenza e la perdita, condizionato anche lui dalla catastrofe del ’22, e influenzato dal simbolismo poetico di Paul Valéry e Jules Laforgue.
Nel panorama letterario greco del secondo dopoguerra, vanno annoverate poi diverse scrittrici di talento. Tra queste, una delle voci più emblematiche è la poetessa ateniese Katerina Anghelaki-Rooke, autrice di circa venti raccolte di poesie, vincitrice nel 1962 del primo premio di poesia della città di Ginevra (Prix Hensch) e nel 1985 del premio nazionale greco di poesia. Oppure, l’attivista politica Alki Zei, candidata al premio Strega Europeo, e tra le più celebri scrittrici di libri per ragazzi. In Italia, il suo romanzo La fidanzata di Achille ha ricevuto il premio Acerbi (2002) e La tigre in vetrina il premio Andersen (2007). Un’altra figura di spicco è la poetessa Kiki Dimoulà, che nel 2010 è diventata la prima autrice greca a essere pubblicata nella collana di poesia dell’editore francese Gallimard. Con loro, troviamo anche Dido Sotiriou con Addio Anatolia (Crocetti, 2022) e Margarita Liberaki con Tre estati (Crocetti, 2021).
Nel 1954, esordisce Antonis Samarakis, uno degli autori greci più tradotti, oppositore del regime di Ioannis Metaxas e della dittatura dei colonnelli. Dal suo romanzo distopico, Lo sbaglio, pubblicato nel 1965 (Aiora, 2018), il regista tedesco Peter Fleischmann ha tratto il film La smagliatura, con Ugo Tognazzi e Michel Piccoli.
Degno di nota anche il romanzo Z. L’orgia del potere di Vassilis Vassilikos, edito nel 1967 (Feltrinelli, 2016), e basato sulla triste vicenda di Grigoris Lambrakis, deputato di sinistra ucciso nel 1963 in pieno centro a Salonicco per mano di un estremista di destra.
In tempi ancora più recenti, i problemi sociali, le nevrosi urbane, i conflitti di genere, le minoranze e la ricerca di una nuova identità occupano uno spazio sempre più ampio nella letteratura greca contemporanea. Tra gli autori di transizione tra i due secoli spicca Petros Markaris, i cui romanzi di denuncia sociale, sono ambientati durante la più recente crisi finanziaria greca. Ioanna Karistiani, sceneggiatrice che racconta di donne forti, alle prese con il mare, il dramma dei profughi e il bisogno di amare, ha vinto il premio nazionale per il miglior romanzo greco nel 2007. Ricordiamo i suoi due romanzi tradotti in italiano: Le catene del mare e I mille sospiri (Edizioni e/o, 2008 e 2022). Di altro genere sono invece le opere di Auguste Corteau, pseudonimo di Petros Chatzopoulos, incentrati sulla discriminazione sessuale, la depressione, la maternità e la morte. Un ruolo decisivo ha avuto il suicidio della madre, la cui vita – e quella di tutta la famiglia – è stata raccontata in Il libro di Katerina (Nutrimenti, 2020). Infine, va ricordato Dimitris Lyacos, autore della trilogia Poena Damni (il Saggiatore, 2022), considerata l’opera più importante della letteratura postmoderna greca.
Foto di Jo Justino da Pixabay
A cura di Clara Frasca