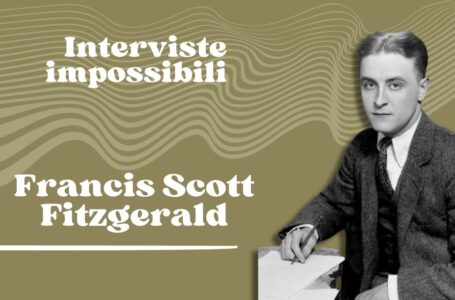Intervista Impossibile a Cesare Pavese: tutto quello che ci avrebbe detto se fosse vivo

«Mangio un poco di cena seduto alla chiara finestra. / Nella stanza è già buio e si guarda nel cielo. / A uscir fuori, le vie tranquille conducono / dopo un poco, in aperta campagna. / Mangio e guardo nel cielo – chi sa quante donne / stan mangiando a quest’ora – il mio corpo è tranquillo; / il lavoro stordisce il mio corpo e ogni donna. / Fuori, dopo la cena, verranno le stelle a toccare / sulla larga pianura la terra. Le stelle son vive, / ma non valgono queste ciliege, che mangio da solo. / Vedo il cielo, ma so che fra i tetti di ruggine / qualche lume già brilla e che, sotto, si fanno rumori».
Cesare Pavese fu uno scrittore, narratore, critico, traduttore e poeta dal carattere nostalgico e anticonvenzionale. Può essere considerato a tutti gli effetti il primo intellettuale italiano moderno, perseguitato dal fascismo, lavorò in Einaudi dove fu direttore durante gli anni della guerra e curò la storica collana Coralli. Ricevette il premio Strega nel 1950 con La bella estate (Einaudi, 1949), pochi mesi prima di suicidarsi.
Abbiamo immaginato di dialogare con lui. Ecco la nostra intervista.
Signor Pavese, la ringrazio per aver accettato di prendere parte a questa intervista. Sono tanti i temi che vorremmo affrontare in questa intervista, ma andiamo per gradi. Si dice che dal dolore nascano dei capolavori. Questo lo si può dire anche di lei? Quando ha iniziato a scrivere?
C’era un tempo che avevo ben vivo nella mente un ammasso passionale e semplicissimo di materia, sostanza della mia esperienza personale da ridurre a chiarezza e determinazione organiche nel poetare e ogni mio tentativo, sottilmente ma inevitabilmente, si riconnetteva a questo fondo, e mai mi parve di sviarmi per stravagante che fosse il nucleo di ogni nuova poesia. Far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa.
Le donne hanno sempre fatto parte della sua vita, in un modo o nell’altro. C’è stata qualcuna da cui si è sentito tradito, umiliato?
C’è stata una donna, Tina Pizzardo. La chiamavo la «donna dalla voce rauca». Al mio ritorno dal confino da Brancaleone Calabro, scoprii che stava con un altro uomo e che intendeva sposarsi. Ricordo ancora cosa le scrissi: «Ti voglio bene cara, e ti odio, sei per me letteralmente l’aria che respiro, se mi manchi ti maledico come fa un annegato; mi fa male fisicamente esser lontano da te; non sei per me una donna, sei l’esistenza stessa; dove sei tu è la mia casa, tutto il resto è niente».
Le porta rancore?
Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Niente pettegolezzi. Vendicarsi di un torto ricevuto è togliersi il conforto di gridare all’ingiustizia.
Ad oggi, riguardando indietro, come descriverebbe il suo rapporto con le donne?
Le donne mentono, mentono sempre e ad ogni costo. E non c’è da stupirsi: hanno la menzogna nei genitali stessi.
E della vita? Come l’affronta?
Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri.
Si dice che lei sia una personalità alquanto emblematica, solitaria.
Vivere tra la gente è sentirsi foglia sbattuta. Viene il bisogno d’isolarsi, di sfuggire al determinismo di tutte quelle palle da biliardo. La sola regola eroica: essere soli soli soli. Quando passerai una giornata senza presupporre né implicare in nessun tuo gesto o pensiero la presenza di altri, potrai chiamarti eroico. L’offesa più atroce che si può fare a un uomo è negargli che soffra.
È stato doloroso sentirsi così «diverso»?
Il dolore non è affatto un privilegio, un segno di nobiltà, un ricordo di Dio. Il dolore è una cosa bestiale e feroce, banale e gratuita, naturale come l’aria. È impalpabile, sfugge a ogni presa e a ogni lotta; vive nel tempo, è la stessa cosa che il tempo; se ha dei sussulti e degli urli, li ha soltanto per lasciar meglio indifeso chi soffre, negli istanti che seguiranno, nei lunghi istanti in cui si riassapora lo strazio passato e si aspetta il successivo. Questi sussulti non sono il dolore propriamente detto, sono istanti di vitalità inventati dai nervi per far sentire la durata del dolore vero, la durata tediosa, esasperante, infinta del tempo-dolore. Chi soffre è sempre in stato d’attesa – attesa del sussulto e attesa del nuovo sussulto. Viene il momento che si preferisce la crisi del nuovo sussulto. Viene il momento che si grida senza necessità, pur di rompere la corrente del tempo, pur di sentire che accade qualcosa, che la durata eterna del dolore bestiale si è un istante interrotta – sia pure per intensificarsi. Qualche volta viene il sospetto che la morte – l’inferno – consisterà ancora nel fluire di un dolore senza sussulti, senza voce, senza istanti, tutto tempo e tutta eternità, incessante come il fluire del sangue in un corpo che non morirà più.
Crede che esista un modo per vivere o superare il dolore?
C’è un’arte di ricevere in faccia le sferzate del dolore, che bisogna imparare. Lasciare che ogni singolo assalto si esaurisca; un dolore fa sempre singoli assalti – lo fa per mordere più risoluto e concentrato. E tu, mentre ha i denti piantati in un punto e inietta qui il suo acido, ricordati di mostrargli un altro punto e fartici mordere – solleverai il primo. Un vero dolore è fatto di molti pensieri; ora, di pensieri se ne pensa uno solo alla volta; sappiti barcamenare tra i molti, e riposerai successivamente le parti indolenzite. Soffrire è sempre colpa nostra.
Il dolore lacera, e alcune persone prendono decisioni non facili. Lei ha mai pensato di compiere un atto estremo?
Bisogna osservare bene questo: ai nostri tempi il suicidio è un modo di sparire, viene commesso timidamente, silenziosamente, schiacciatamente. Non è più un agire, è un patire. La difficoltà di commettere suicidio sta in questo: è un atto di ambizione, che si può commettere solo quando si sia superata ogni ambizione. Ma la grande, la tremenda verità è questa: soffrire non serve a niente.
Ha paura della morte?
M’atterrisce il pensiero che io pure dovrò un giorno lasciare questa terra, dove i dolori stessi mi sono cari poiché tento di renderli nell’arte. E più tremo pensando all’agonia, alla lunga terribile agonia che forse andrà dinanzi alla mia morte. Che cosa è mai la vita ai moribondi che ancor comprendono e si sentono lenti, lenti spirare in una stanza tetra soli in sé stessi? Oh, conoscessi un Dio, così vorrei pregarlo: quando il petto mi si gonfia ricolmo di un’ondata di poesia ardente e dalle labbra mi sfuggono rotte parole, che ansioso m’affanno a collegare in forma d’arte, quando più riardo e più deliro, oh, allora mi si schianti una vena accanto al cuore e soffochi così, senza rimpianto.
A cura di Cristina Stabile